
[rating=3] Grande è, certo, la casa di Medea: la vede, sul palco aperto, senza le cortine del sipario, il pubblico che arriva al Teatro Mercadante, qui a Napoli, e tavoli e sedie e letti e cassapanche di legno a render confortevole la vita di chi ci abita; sul davanti una striscia di terra delimita – e sottolinea, insieme, il dono e la maledizione dell’humus e delle radici forti e inestinguibili – l’invisibile immaginaria quarta parete; hanno gli altri muri, invece, un che di rugginoso e ferrigno aspetto, rumore di percosse lamiere al tocco ed odore d’ossidazione e calcarea incrostazione, dovuta certo all’aria e soprattutto all’acqua, la cui presenza è infatti più che un’intuizione, nello squadrato lavandino a sinistra e nella doccia a destra, posta in una rientranza della parete che poi si rivelerà esser un bagno.
L’acqua è dunque forte presenza, in questa Medea messa in scena da Gabriele Lavia: la sete della protagonista a segno e simbolo assurge del desiderio suo implacabile e tormentoso, nella negazione dolorosa d’erotismo smemore e sfilacciato, nell’acqua si scioglie il veleno che imbeve l’abito assassino che staccherà le carni dalle ossa della principessa, nuova sposa di Giasone, nell’acqua cercherà infine – invano, probabilmente – ella conforto e purificazione, nel lavacro finale che l’accoglie sotto la doccia, lasciati lontano gli abiti insanguinati e i pensieri di morte, quando ormai tutto è compiuto.

È, dunque, una Medea antica e insieme contemporanea, quella che Lavia sceglie di rappresentare, fuori dunque dal tempo e dallo spazio, o meglio in un tempo e spazio eterni, immutabili pur nell’infinita variabilità e incostanza loro; utilizza per ciò la versione in prosa di Maria Grazia Ciani, dai dialoghi che hanno il dono di render concetti e pensieri in modalità ch’assume il sapore di straordinaria attualità e ordinarietà; i costumi di Emanuele Zero, che sceglie per lei un lungo abito nero che, se da un lato si contrappone ai tenui e colorati abitini delle donne del coro, per altro verso l’associa ai personaggi maschili, anch’essi vestiti di nero: straordinario modo, nella semplicità più grande, di sottolineare i caratteri precipui di Medea, terribilmente attuali, il contrasto, cioè, tra etnie e quello di genere, che attraversano il capolavoro di Euripide e ne consacrano, da sempre, l’eternità; e poi le scene di Alessandro Camera, cui abbiamo accennato, che creano una scansione dello spazio che, se da lontano vagamente ricorda lo skyline d’una moderna polis, coi suoi grattacieli parchi quartieri, dall’altro è invece ambito d’abitazione, privato e pubblico tuttavia, lager di pensieri prigionieri e doloranti, arena in cui l’onnipresente protagonista accoglie le donne di Corinto, il re, il marito, i figli, conducendo il gioco suo perverso e aggrovigliato, lucido e confuso insieme.
Donna straniera in terra straniera, figlia di un sole che sorge lontano, laggiù a oriente, nella remota Colchide dedita ad arti barbare e ormai superate dal progredir dei tempi, come la magia e il veneficio, questa Medea fa emergere tutte le contraddizioni della presunta superiorità della civiltà greca (e occidentale in genere), la messa al bando e l’ostracismo da parte della polis civile e ordinata, l’ostinata e cieca ricerca di moderazione (e quanto costa in umanità l’olimpica sicurezza e tranquillità), la mentalità – diremmo noi – piccolo borghese dell’eroe protagonista in cerca d’una buona sistemazione: Medea non capisce, Medea non ci sta, Medea reagisce nel peggiore dei modi, con una ritorsione spropositata, al limite della comprensione umana.
Certo, mi piace pensare che abbia ragione Robert Graves, suggestivamente affermando la storica(?) verità d’una Medea commissionata (quindici talenti d’argento il prezzo, che tanto ricordano l’esborso d’altro e più famoso tradimento) al Maestro Euripide dalla città di Corinto, per far ricadere la colpa dell’omicidio dei figli di Giasone e dei misfatti di Re Creonte sulla strega straniera, e mai macchina mediatica fu così efficace, mai menzogna detta così bene, tanto che già ai tempi di Seneca – primo di tanti a rimeditar sulla tragedia – il nome era diventato comune sostantivo ad indicar la madre che uccide i figli, distogliendo così – arma perfetta di distrazione di massa – l’attenzione dalla verità, oscena miscela invece di razzismo e sessismo violento, ch’avrebbe, in mancanza d’Euripide, diversamente colorato l’alba della civiltà greca: tuttavia, proprio perché mette in luce, per chi le sa vedere e leggere, le perenni contraddizioni del potere, Medea acquista l’eternità, ch’è sempreverde contemporaneità: la felice messa in scena di Lavia ne è esempio lampante.

Federica Di Martino è il volto, il corpo, il sangue e l’anima di Medea, al tempo stesso feroce e calcolatrice, ferina nelle movenze come animale ferito e stanco, che sa trovare nella sua disperazione la forza per reagire: la credibilità dell’attrice si fonde alla fine con l’iperbole del personaggio, facendo diventar perfino plausibile, quasi ordinaria, la follia del gesto, della morte che s’annuncia prima, poi s’invera, in uno con la lacerazione percettiva d’un suono fortissimo e inumano, un che di strappo e di ferita, dilaniarsi lento e rapido al tempo stesso delle nostre certezze e del nostro pensarci civili.
E fin troppo misurato e moderato è l’eroe Giasone, che ha la faccia di Daniele Pecci, tanto da finir limitato, chiuso in una cecità perfino più folle della pur grande pazzia della moglie, asfittico nella manifesta sua impossibilità di figurarsi un diverso altrove che non implichi onori, ricchezze, prebende ed agi; vicino a lui, in qualche modo affine nell’incrollabile certezza loro d’appartenere alla fortunata razza padrona, è pure Creonte, cui dona giusta rozzezza ed impeto violento Umberto Ceriani.
Diversi, perché esclusi dal pattuire e guerreggiare dei potenti, l’arcana nutrice di Angiola Baggi, il rassegnato pedagogo di Pietro Biondi, il turbato messaggero di Gabriele Anagni: l’universo della gente umile che, pure, ha abbastanza autonomia di giudizio da potersi formare un’opinione vera e personale dei fatti, in alternativa al sentir comune, fatto di frasi fatte e ordinari mediocri pensieri e false credenze, rappresentato dal Coro delle donne corinzie, in un musicale contrappunto spesso efficace e stimolante.
Il pubblico, che ha riempito il Teatro, ha partecipato in religioso silenzio, per liberare, alla fine, la tensione, in un lungo e intenso applauso.


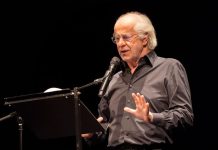












una nota> il messaggero e’ francesco sferrazza papa, creonte e’ mario pietramala e il pedagogo giorgio crisafi