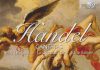Ci saremmo aspettati il classico sold out, per questo Concerto di delizie neoclassiche che chiude la Stagione Sinfonica del Teatro San Carlo qui a Napoli: la leggiadria dei pezzi – scelti probabilmente ispirandosi ad un desiderio di non scontata serenità che sfocia nel sogno di mondi utopici e lontani – in uno con la fama degli esecutori – il direttore e violinista Pinchas Zukerman e la violoncellista Amanda Forsyth, insieme alla nostra Orchestra del Teatro San Carlo – avrebbero fatto prevedere un pubblico ben più numeroso. Così non è stato e dispiace, perché le occasioni di sentire buona musica ottimamente eseguita si faranno, di questo passo, sempre più rare, con un generale impoverimento che, in tutta evidenza, non danneggia solo l’Arte o la Musica ma investe ogni aspetto del nostro vivere civile. Il programma prevedeva, nella prima parte, un brano per sola orchestra, la mozartiana Ouverture delle Nozze di Figaro, che fungeva effettivamente da ottimo antipasto per un primo piatto costituito da pezzi in cui potesse risaltare lo strumento dei solisti, sia il violoncello di Amanda Forsyth, con Les larmes de Jacqueline, per violoncello e orchestra, op. 76, n. 2, di Jacques Offenbach, seguito dal Divertimento in re maggiore per violoncello e orchestra di Franz Joseph Haydn; alla fine di questa prima parte, il Concerto n. 1 in do maggiore per violino e orchestra d’archi dello stesso Haydn, in cui, invece, è il violino di Zukerkman ad essere in primo piano.
Tanto si è detto e scritto a proposito delle istanze sociali presenti ne Le nozze di Figaro, sì da far addirittura supporre alla più recente critica un intervento diretto dell’Imperatore Giuseppe II che avrebbe ottenuto da Da Ponte, nella trasposizione dalla commedia di Beaumarchais (che si portava dietro problemi di censura) l’omissione delle parti più “politiche” senza intaccare, tuttavia, la sostanza della trama. In ogni caso, al di là della carica fortemente critica nei confronti dell’aristocrazia, Mozart e Da Ponte si pongono senz’altro in una dimensione superiore, quella della commedia umana, in cui tutto, amore, gelosia, riscatto di classe, malinconia, leggerezza, si confonde e si integra in un panorama di emozioni scevro da qualsiasi giudizio morale.
La stessa Ouverture è un perfetto esempio di come tradizione e innovazione trovino un punto di equilibrio pressoché perfetto: al contrario dal dettame della consuetudine, che suole specchiar nell’Ouverture i temi principali dell’opera, essa brilla di luce propria, tanto da essere spesso eseguita, come in questo caso, nel corso di un concerto, senza che questo minimamente intacchi il profondo senso di joie de vivre che immancabilmente procura nell’ascoltatore anche profano. Decide, Zukerkman, di dare un taglio di decisa compostezza, a questo brano in cui spesso la temperatura emotiva s’innalza ad altissimi livelli: intendiamoci, la musica e il ritmo è sempre scintillante, il suono sempre bello, i dettagli perfetti, ma più che selvaggia allegria la percezione era di composto, sorridente equilibrio: un Mozart sereno che nella sua trasparenza ha dato il la all’ìntera serata.
Offenbach compose Les larmes de Jacqueline (Le lacrime di Jacqueline), op.76 n. 2, nel 1846 come secondo di una serie di tre pezzi dal titolo Les Harmonies des Bois. Prima di essere il grande autore di opere teatrali che conosciamo – detto per inciso, intraprese questa particolare carriera quando si accorse che i soldi che guadagnava come solista di violoncello non erano abbastanza – Offenbach scrisse ed eseguì una lunga serie di pezzi per questo strumento – alla morte assommeranno a ben 75 – tra cui questo, composto proprio viaggiando in tutta Europa esibendosi come virtuoso di violoncello, spesso eseguendo la propria musica, insieme a Friedrich von Flotow.

Nella storia del violoncello, lo sviluppo di questo strumento conosce il punto più alto proprio durante secolo romantico: la tecnica si affina, grazie alla posizione del pollice che consente ora di raggiungere il registro acuto, che si traduce, a sua volta, nella conquista di un mai troppo desiderato virtuosismo e i più grandi del tempo, Chopin, Lalo, Beethoven, Meldelssohn, Shumann, Saint-Saëns, Brahms scrivono ormai musica per questo strumento, che ormai non ricopre più solo il ruolo di accompagnamento: una serie di grandi violoncellisti, oltre allo stesso Jacques Offenbach, come David Popper, Jean-Louis Duport, Bernhard Romberg esplorano ogni potenzialità dello strumento.
Il lavoro ha guadagnato ulteriore popolarità dal celebre virtuoso di violoncello Jacqueline du Pré (1945-1987), che ha dato molte memorabili interpretazioni del pezzo. Amanda Forsyth, compagna di vita di Pinchas Zukerman, oltre che eccelsa solista di questo strumento, ha saputo dare, di quest’opera potente e al tempo stesso delicata, un’interpretazione eccellente per tecnica e assoluto valore musicale, regalando grande emozione al pubblico, in particolare ha impressionato la squisita espressività che, apparentemente senza sforzo, sembrava fluire dalla mani e dall’arco, in serrato ed appassionato dialogo col primo violoncello Luca De Muro, poi ringraziato tra gli applausi dalla stessa solista, a conferma, se necessario, della grande professionalità degli artisti dell’Orchestra del Teatro San Carlo.
“Il principe era pienamente soddisfatto del mio lavoro, ero apprezzato, avevo a disposizione un’orchestra per fare esperimenti ed osservare cosa rafforzava e cosa indeboliva un effetto e quindi potevo perfezionare, cambiare, eliminare e provare soluzioni nuove; ero isolato dal mondo, non c’era nessuno intorno a me che potesse sviare o turbare il mio lavoro e così fui costretto a diventare originale”: il trentennale lavoro di Haydn presso i principi Esterhazy viene descritto, dallo stesso musicista, come una condizione ideale per poter sviluppare appieno la concezione musicale del suo genio, che trova riscontro nelle Sinfonie e nei Quartetti, costruzioni che partono dalle premesse iniziali in un percorso e sviluppo essenzialmente razionale, logico, nell’equilibrio ed essenzialità della materia. Non tutto è invece così rigoroso nei Concerti, dal carattere sicuramente più leggero e disimpegnato, ma certamente non secondi per grazia e brio, serenità e nitore: ne son prova il Divertimento in re magg. per violoncello e orchestra, presentato nella trascrizione di Grigorij Pjatigorskij, che vede ancora protagonista il violoncello della Forsyth e il Concerto n. 1 in do maggiore per violino ed orchestra d’archi, in cui, invece, è il violino di Zukerman a far la parte del leone.
Opere di “transizione” tra il morente barocco e il nascente neoclassico, in cui lo schema tipico d’alternanza tra solista e orchestra risponde a dinamiche più propriamente barocche, mentre certamente lo sguardo è rivolto al futuro nella galante vena cantabile che attraversa i due brani, con i solisti impegnati in severi passaggi di agilità che ne esaltano la maestria tecnica in un tour de force serrato che sembra non aver mai fine. La seconda parte apre decisamente al sogno e all’immaginazione di diversi mondi e di diverso sentire, partendo dall’Overture del Flauto magico di Mozart per arrivare alle musiche di scena del Sogno di una notte di mezza Estate, op. 61 di Felix Mendelssohn, di cui si eseguono tre soli movimenti: Scherzo, Notturno, Marcia Nuziale.

Die Zauberflöte, al di là di ogni discussione circa la sua genesi e i suoi molteplici significati, solo a condizione di considerarla opera pervasa di mistero, soffusa d’un’aura favolosa, è possibile entrare dentro il suo mondo, costituito da accadimenti scenici e musicali seguendo una dinamica eminentemente teatrale, sganciata però da qualsivoglia logica drammatica coesa, stringente e unitaria. Anche l’Ouverture è accuratamente progettata: in questa straordinaria pagina sinfonica tutto funziona alla perfezione, con gran cura non solo dell’aspetto prettamente musicale ma soprattutto pensata e concepita come totale compenetrazione tra linguaggio musicale e simbolismo, incorporando elementi massonici – cominciando dalla tonalità di mi bemolle maggiore, sia perché ha tre bemolli in chiave ma pure perché costituisce la tonalità tipica dell’espressione della religio privata mozartiana – ed elementi narrativi del libretto. La tecnica di Zukerman è, come sempre, di alto livello, la grande purezza del suono, cristallino e nitido, è sempre circonfuso d’un’aura arcadica che immagini rinviare ad un universo altro e incognito.
Com’è noto, le cosiddette “musiche di scena”, genere particolare della sensibilità romantica, vengono considerate composizioni in qualche modo figlie d’un dio minore, strette come sono tra l’esigenza “funzionale” dell’occasione – la performance drammaturgica – per cui venivano composte e quella “riassuntiva”, che in qualche modo apparenta la Sinfonia iniziale con l’Ouverture d’un’opera lirica, e questo è, tra l’altro, il motivo per cui, di solito, nel repertorio concertistico trovano posto solo tali Sinfonie. Ma le musiche di scena per il Sogno di una notte di mezza estate, composte da Meldelssohn nel 1842, sono la classica eccezione che conferma la regola: se l’Overture è famosissima, altrettanto lo sono altri brani dei dieci che strutturano il ventaglio sinfonico, e non di rado la composizione viene eseguita per intero.
Il programma del nostro Concerto ha previsto, invece, l’esecuzione di solo tre brani: lo Scherzo seguiva normalmente l’Ouverture e veniva eseguito a conclusione del primo atto, portando in dote una straordinaria scrittura musicale che, di certo, non lo farebbe sfigurare come terzo movimento d’una classica sinfonia, e il taglio che Zukerkman decide è proprio questo, insistendo sul perfetto equilibrio formale, d’eccezionale levità e coesione, sottolineando il raffinato pendant tra i due temi del brano, differenti, in definitiva, solo per il modo (minore e maggiore). Il secondo movimento eseguito è in effetti il sesto, il Notturno, con forma tripartita tipica dei movimenti lenti, con un’ampia melodia dolce e romantica, affidata a corni e fagotti, affascinante soprattutto per la sua sua semplicità.
L’ultimo brano è il settimo, la celeberrima Marcia nuziale, occasione senza pari per Zukerman per far rifulgere appieno lo splendore dell’orchestra romantica, che fece dire a Liszt: “Questa musica vibra di frizzante originalità, di armonia ed eufonia, in una fusione organica di elementi eterogenei”. Molti gli applausi, alla fine, con numerose chiamate e richieste di bis, che il direttore violinista concede solo in parte, facendosi prestare un violino dall’Orchestra e accennando, chiedendo l’aiuto del pubblico a canticchiarla, l’altrettanto celeberrima Ninna nanna di Brahms che, in modo spiritoso, chiude questa magica e classicamente serena serata.