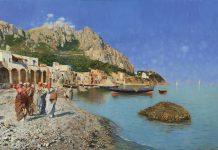Palazzo Strozzi ospita fino al 18 luglio la mostra De Chirico, Max Ernst, Magritte, Balthus. Uno sguardo nell’invisibile, dal fascino inquietante, che racconta la straordinaria avventura artistica di Giorgio de Chirico e la duplice influenza che ebbe la sua pittura nell’arte moderna e su pittori a lui contemporanei.
Articolandosi in 100 opere, provenienti da esclusive raccolte private e da alcuni dei maggiori musei del mondo, la rassegna pone al centro “la rivoluzione copernicana” operata da De Chirico nell’arte del XX secolo, che aprì la strada a molteplici movimenti artistici, dal Dada al Surrealismo, dal Realismo Magico al Neo-Romanticismo: si riflette sui temi degli spazi e dei sogni.
Tutto prende inizio da un viaggio a Firenze in un “chiaro pomeriggio d’autunno” quando il ventunenne Giorgio De Chirico, seduto su una panchina in piazza Santa Croce, ebbe la “strana impressione di vedere quelle cose per la prima volta. E la composizione del quadro si presentò al mio spirito; e ogni volta che guardo questo dipinto rivivo quel momento: momento che tuttavia è un enigma per me, perché è inesplicabile”. E proprio questa visione fiorentina del 1909 darà il via alla stagione della Metafisica e si rivelerà “una rivelazione per il mondo intero”, una ricerca della verità, ovvero realtà profonda e autentica delle cose, che trova il suo ideale in una concezione nichilista della realtà e della materia, grazie ad esempi quali Eraclito, Schopenhauer, Nietzsche, in una ricerca spasmodica di “far vedere ciò che non si può vedere”, un nulla che invita a esplorare l’instabilità dei linguaggi e la sconcertante pluralità semantica dei segni.
La mostra, dunque, prende corpo da capolavori di De Chirico quali L’enigma dell’arrivo e del pomeriggio (1911-12), La nostalgia dell’infinito (1912), Il trovatore (1917), I platonici (1925) per poi ramificarsi tra i suoi illustri contemporanei che hanno tessuto stretti legami con quell’arte dello spaesamento. Ecco allora Carlo Carrà con il celebre L’ovale delle apparizioni(1918) o Il gentiluomo ubriaco (1916); Giorgio Morandi con le sue nature morte metafisiche; Alberto Savinio che dà parole, forme, colori, suoni al proprio mondo poetico in opere quali Il vecchio e il nuovo mondo (1927) o Il sogno del poeta (1927); Max Ernst, artista surrealista che afferma in primis “all’uomo moderno, dunque, il compito di liberarsi della propria cecità”, manifesto emblematico del suo Edipo re (1922) e delle sue molteplicigouache; Renè Magritte, che definisce l’arte di De Chirico “una nuova visione nella quale lo spettatore ritrova il suo isolamento e intende il silenzio del mondo”, con opere quali Il senso della notte (1927), La vita segreta(1928), La condizione umana (1933), Balthus che, in opere quali Giovane addormentata (1943) e Le passage du Commerce-Saint-Andrè (1952-54), “più che offrirci un oggetto di contemplazione, […] ci mette nell’attesa dello spettacolo che in realtà stiamo già vedendo” come afferma Pierre Klossowski. Ma ancora troviamo Arturo Nathan, Pierre Roy e uno dei maggiori rappresentanti del Realismo Magico di area tedesca, ovvero Niklaus Stoecklin, presente con nove opere.
Ovunque aleggia alienazione e solitudine, senso di abbandono, isolamento, eredità diretta di quell’abisso generato dalla violenze e crudezza della guerra: gli uomini si ritrovano allora prigionieri, attori privati di parole ed azioni.
Una mostra enigmaticamente calamitante, da sorseggiare lentamente e in silenzio, che immerge in un’attesa senza tempo.
All’interno è possibile svolgere anche un percorso per famiglie e bambini che invita ad esplorare la psicologia attraverso speciali didascalie e una sala interattiva che accompagneranno il visitatore in un viaggio nel mondo dei sogni, degli spazi e delle paure.
Per info
T. +39 055 2645155
Sito web www.palazzostrozzi.org