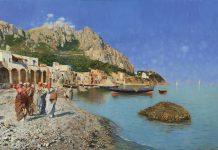Visitare la mostra su Caravaggio a Roma è come fare anche un viaggio nella sua vita, attraverso le 24 opere esposte fino al 6 luglio nelle sale di Palazzo Barberini in Via delle Quattro Fontane.
A cominciare dal legame dell’artista con questa città, nella quale Michelangelo Merisi arriva più o meno ventenne dalla cittadina lombarda di Caravaggio, dove era nato nel 1571. Roma lo vede nascere e crescere come artista ed è una delle due città più importanti della sua vita, insieme a Napoli, ma di questo parleremo poi.
L’impatto all’entrata della mostra è perfettamente “caravaggesco”: così come nei quadri le figure emergono dal fondo scuro in tutta la loro meraviglia di luce e colore, all’entrata le opere alle pareti risplendono nella penombra della prima sala espositiva.
L’occhio fugge subito alla grande tela in fondo alla stanza, la Conversione di San Paolo. Ma è bene resistere alla tentazione di andare dritti verso quell’opera, e procedere invece per tappe, per ammirare lungo i lati le prime opere del Caravaggio: il Ragazzo che monda un frutto, il Bacchino malato, il Narciso (per quanto quest’ultimo ancora di non unanime attribuzione).
E poi opere come I bari, la zingara che legge la mano nella Buona ventura e San Francesco d’Assisi in estasi, nelle quali l’artista ha già in parte individuato il suo percorso stilistico.

In questi anni romani Caravaggio si afferma e ottiene due importanti commissioni, la prima per la chiesa di San Luigi dei Francesi (dove si possono ammirare la Vocazione di San Matteo, il Martirio di San Matteo e San Matteo e l’angelo) e la seconda per la chiesa di Santa Maria del Popolo. E qui torniamo all’opera che prima ci aveva colpito a distanza: la Conversione di San Paolo, prima “edizione” (su legno di cipresso) di un quadro la cui versione su tela si trova appunto a Santa Maria del Popolo.
Correva l’anno 1600 e questa Conversione rompe con la tradizione, mostrando non tanto l’elemento divino – niente folgori e lampi di luce dal cielo, per intenderci – ma solo il suo impatto terrifico su Saulo (cioè San Paolo) e sugli altri presenti, atterriti da qualcosa di invisibile ma irresistibile.
E passiamo alla seconda sala che ti accoglie con due ritratti al cardinale Maffeo Barberini. Ma lo sguardo dirotta subito a destra su una parete tutta dedicata alla celebre Giuditta che decapita Oloferne. Qui dovrai avere un po’ di pazienza per trovarti da solo davanti al quadro, perché dal vivo rapisce e tiene tutti incollati alla scena. Ci sono Marta e Maria Maddalena e c’è Santa Caterina d’Alessandria, che merita una particolare attenzione perché è una di quelle opere in cui Caravaggio inizia con maggiore convinzione a calcare la mano sul contrasto tra buio e luce, tra ombre e colore. Come scrive il critico e biografo Pietro Bellori, Caravaggio si mette a “ingagliardire gli oscuri”.
Nella terza sala entriamo nella fase pittorica di Caravaggio dedicata quasi esclusivamente all’arte sacra. Da una parte all’altra della stanza sembrano richiamarsi a vicenda due momenti iconici della vita di Cristo, la Cattura e la Flagellazione.
Ai lati San Giovanni Battista, San Francesco in meditazione, Davide con la testa di Golia e ancora Cristo, ma nella più serena atmosfera della Cena di Emmaus. E c’è un’opera che per le sue minori dimensioni potrebbe rischiare di attirare meno l’attenzione, e che è invece protagonista d’eccezione di questa mostra: l’Ecce Homo, rinvenuta e attribuita a Caravaggio solo nel 2021. Queste opere a tema sacro appartengono al periodo a cavallo tra Roma e Napoli, quando cioè il nostro deve scappare dalla capitale per aver ucciso in una rissa Ranuccio Tomassoni, altra testa calda che scorrazza in città.

Quando ritiene che neppure Napoli sia abbastanza sicura, fa rotta su Malta e riesce a entrare nell’Ordine cavalleresco. Di questo periodo è il Ritratto di Cavaliere di Malta che apre la quarta e ultima sala. Quindi scappa anche dall’isola, dove è stato imprigionato ed espulso dall’Ordine per aver ferito un altro cavaliere (in una rissa, ca va sans dire). Torna a Napoli e in questo secondo soggiorno partenopeo dipinge il Martirio di Sant’Orsola, forse la sua ultima opera.
Un quadro particolare, che si distingue per il chiarore lunare di cui sembra risplendere la santa. Anche in questo, come in diversi altri dipinti, Michelangelo appone la “firma” di un suo autoritratto, come a rafforzare ulteriormente quel legame tra la sua arte geniale, la sua personalità sopra le righe e la sua rocambolesca vita.
Vita che termina – in circostanze mai davvero chiarite – a Porto Ercole a soli 39 anni, durante il vano tentativo di tornare a Roma dove probabilmente lo aspetta il perdono di papa Paolo V (Camillo Borghese). Come ringraziamento, Caravaggio vorrebbe donare al papa e a suo nipote Scipione Borghese una delle sue ultime opere, un San Giovanni Battista. Non ne ha il tempo. A quel San Giovanni possiamo riservare l’ultimo sguardo, e lui a noi, mentre usciamo dalla mostra.