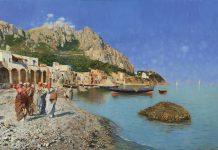La redazione del magazine cresce ulteriormente facendo entrare nel suo staff la firma di Francesco Sinacori. Laureato in Conservazione dei Beni Culturali a Pisa, è specializzato su Leonardo da Vinci, sul quale ha presentato un libretto didattico per la fondazione Carifi, in collaborazione con il museo Ideale Leonardo Da Vinci di Vinci. Ha lavorato per numerosi musei del territorio fiorentino, svolto attività di guida e accompagnatore per numerose mostre e curato laboratori didattici presso scuole e musei.
Oggi ci guiderà alla scoperta dello scultore Antonio Corradini e delle velate di San Severe a Napoli, tra alchimia ed esoterismo.
Sono poche e contraddittorie le notizie sulla vita di Antonio Corradini: si sa che nacque ad Este (Padova) il 6 settembre 1668 . Nel 1711 risulta iscritto all’Arte dei Tagliapietra tra i lavoranti scultori. Nel 1713 aveva già bottega propria. Il Corradini risulta scultore molto attivo in Veneto, Emila, Campania, nel Lazio ed anche in Europa, in Austria per l’imperatrice Maria Teresa, in Russia per lo Zar Pietro Il Grande, Ungheria dove lavora per i più grandi Sovrani e nobili. Fu amico di Giovanni Battista Piranesi con cui divide l’alloggio a Roma, nella città eterna viene interpellato per il restauro della cupola di San Pietro.
Nel 1749 è a Napoli dove si lega alla massoneria napoletana e lavora nella Cappella San Severo, suo fratello massone. Per tale cappella si occupa di realizzare una decorazione assai complessa ed articolata di cui ci rimangono statue, basamenti, dossali tondi e bassorilievi, per cui prepara 36 modelli in creta, tra cui il Cristo Velato, opera che rimane incompiuta per la morte dell’artista (12 agosto 1752).
Antonio Corradini è sepolto nella chiesa parrocchiale di santa Maria della Rotonda il giorno stesso della sua morte, ed è da qui che comincia la nostra storia.
La Cappella di San Severo a Napoli

«Chiunque tu sia, o viandante, cittadino, provinciale o straniero, entra e devotamente rendi omaggio alla prodigiosa antica opera: il tempio gentilizio consacrato da tempo alla Vergine e maestosamente amplificato dall’ardente principe di Sansevero don Raimondo di Sangro per la gloria degli avi e per conservare all’immortalità le sue ceneri e quelle dei suoi nell’anno 1767. Osserva con occhi attenti e con venerazione le urne degli eroi onuste di gloria e contempla con meraviglia il pregevole ossequio all’opera divina e i sepolcri dei defunti, e quando avrai reso gli onori dovuti profondamente rifletti e allontanati».
Con queste parole il viandante viene accolto nella cappella voluta dal Principe Raimondo di San Severo, inscrizione questa che si trova sulla cornice di una porta in una cappella laterale antico accesso alla cappella e che ci introduce ad un luogo molto particolare ed addirittura magico.
Fu’ Giovan Francesco di Sangro, dopo essere guarito da una malattia che lo aveva quasi condotto alla morte, ad erigere “una picciola cappella” dedicata alla Vergine come ex-voto fatto durante la malattia.
Ma fu’ Raimondo di Sangro, principe di Sansevero, ad iniziare i grandi lavori di restauro e di ampliamento della Cappella.
La Cappella ha suscitato per secoli, alimentato anche dalle storie animate intorno alla figura del Principe, un alone di mistero che va però ben oltre il valore estetico delle opere ivi conservate. Infatti all’interno della Cappella il principe ha collocato numerosi laboratori sotterranei, dove lavorava alle sue scoperte ed invenzioni che andavano ad alimentare la fantasia e le leggende su l’ideatore.
Tra le leggende ne esiste una che afferma di come il Principe avesse fatto uccidere due servi per imbalsamarne i corpi, chiaro è il riferimento alle macchine anatomiche, conservate proprio in uno dei laboratori e di cui ancora oggi non riusciamo a capirne il metodo impiegato per realizzarle.
Si dice anche che dopo aver realizzato il Cristo Velato fece accecare l’autore il Sanmartino in modo che questi non potesse replicarla. Molte altre sono le leggende su questa figura estremamente controversa. Una delle più particolari la cita il filosofo Benedetto Croce, che a Napoli morì, questi afferma:
«Quando sentì non lontana la morte, provvide a risorgere, e da uno schiavo moro si lasciò tagliare a pezzi e ben adattare in una cassa, donde sarebbe balzato fuori vivo e sano a tempo prefisso; senonché la famiglia […] cercò la cassa, la scoperchiò prima del tempo, mentre i pezzi del corpo erano ancora in processo di saldatura, e il principe, come risvegliato nel sonno, fece per sollevarsi, ma ricadde subito, gettando un urlo di dannato».

Molti studiosi dell’esoterismo fanno del Tempio del Principe Raimondo di Sangro uno dei luoghi della “cultura alchemica”: paragonandola ad altre dimore filosofali come le cattedrali gotiche di Notre-Dame de Paris e d’Amiens, dove esistono simbologie comuni legate ai riti di iniziazione prima templari ed in seguito massonici.
Da considerare anche l’utilizzo delle scienze occulte a cui il principe avrebbe fatto ricorso (vedi nota di B. Croce ) che alimentano la fama di Napoli come una città magica al pari di Torino, Praga e Lione.
Cenni architettonici
La cappella è a navata navata unica risalente al 1590 circa ed a forma rettangolare a cui si accede dal fondo Ci sono otto cappelle laterali (quattro per lato) che si dipanano fino all’altare maggiore. Sul lato destro si apre una porta a cui si accede alla cavea sotterranea ed alla tomba del Principe. Tutte le opere, salvo quattro, furono commissionate da Raimondo di Sangro.
Particolare importanza è da attribuire alla pavimentazione, progettata dal principe e di cui ancora oggi non si ignora il procedimento realizzativo, costituita da un mosaico bianco e nero rappresentante un labirinto e di cui oggi, purtroppo, rimangono solo dei frammenti perché sostituiti nel xx secolo.
Il disegno prevede l’alternarsi di croci gammate (o svastiche) simbolo antichissimo e simboleggiante il sole, formate da marmo bianco, con quadrati concentrici collocati in prospettiva. Le tarsie policrome presentano diverse sfumature, dal blu al bianco, dando così profondità alla composizione. Le origini del labirinto si perdono nella notte dei tempi e stanno ad indicare la difficoltà dell’itinerario che deve compiere l’iniziato per approdare alla conoscenza. I labirinti sono presenti in moltissime cattedrali gotiche e più in generale nelle cosiddette “dimore filosofali”, ma anche nel battistero del duomo di Firenze e stanno a rappresentare l’immagine alchemica della Grande Opera.
Le altre opere furono commissionate ad autori contemporanei come Francesco Celebrano, Antonio Corradini, Francesco Querciolo e Giuseppe Sanmartino.
Opere e scultore
Attorno al 1750, Corradini ormai in età avanzata comincia a lavorare ai modelli in terracotta delle statue e degli apparati, d’accordo con il Principe Di Sangro. Il Principe Di Sangro vuole dedicare le prime sculture ai suoi genitori. Alla madre, perché morta giovanissima, ed al padre perché per curare gli affari di famiglia era sempre in viaggio. Allora il Corradini realizzò la statua della Pudicizia, mentre al genovese Queirolo quella del Disinganno, su idea del Corradini.

La Pudicizia è caratterizzata dalla presenza del velo che svela, forse dovuto al fatto che il Principe non avesse conosciuto molto la madre, perché deceduta molto giovane e da qui l’allusione al velo della morte che maschera il volto della madre ma che svela invece il ricordo sempre vivo in Raiomondo, colei che con la sua prosperità, vedi seni scoperti, lo ha generato.
Altri temi altamente simbologici sono la lapide spezzata che ci riporta alla sapienza velata e inviolabile per chi non è iniziato ai suoi misteri. L’incensiere è fondamentale per ogni cerimonia e quindi anche per i massoni. Gli arbusti di quercia e quelli di acacia invece rappresentano rispettivamente la consapevolezza del bene e del male ed il simbolo per eccellenza della massoneria che ne rappresenta la sua vitalità, il suo vigore, la solidità del suo legno, la profondità delle sue radici, la gentilezza del suo fogliame, la fragranza delicata dei suoi fiori.
La statua del Disinganno invece è di particolare pregio per quanto riguarda la rete che simboleggia gli inganni e che avvolge il personaggio, allegoria del padre e di se stesso; il padre perché per affari era sempre fuori Napoli a curare gli interessi della sua famiglia e del principe perché costretto a vivere fin da bambino privo degli affetti della madre e del padre. Il personaggio però viene liberato da cui un genio alato che lo aiuta, simbolo della intelligenza e della arguzia che favorisce gli audaci e gli studiosi. Mentre la spalla sinistra scoperta del cieco era un requisito richiesto agli iniziati alla massoneria.

Ma l’opera più somma è quella del Cristo disteso e velato, eseguito dallo scultore napoletano di presepi artistici Giuseppe Sanmartino (1720-1793), ma su indicazione del Corradini.
Opera che ancora oggi ci stupisce per la sua veridicità e che anche Antonio Canova tentò di acquistare dichiarandosi disposto a dare dieci anni della propria vita pur di essere l’autore di un simile capolavoro.
Scovando tra gli archivi notarili di Napoli dei ricercatori hanno individuato un atto del 1752 che ci svela la ricetta del velo:
“Calcina viva nuova 10 libbre, acqua barilli 4, carbone di frassino. Covri la grata della fornace co’ carboni accesi a fiamma di brace; con ausilio di mantici a basso vento. Cala il Modello da covrire in una vasca ammattonata; indi covrilo con velo sottilissimo di spezial tessuto bagnato con acqua e Calcina. Modella le forme e gitta lentamente l’acqua e la Calcina Misturate. Per l’esecuzione: soffia leve co’ mantici i vapori esalati dalla brace nella vasca sotto il liquido composito. Per quattro dì ripeti l’Opera rinnovando l’acqua e la Calcina. Con Macchina preparata alla bisogna Leva il Modello e deponilo sul piano di lavoro, acciocché il rifinitore Lavori d’acconcia Arte. Sarà il velo come di marmo divenuto al Naturale e il Sembiante del modello Trasparire”.
Il Principe aveva inoltre costretto ad Il Sanmartino ad impegnarsi a non rivelare il procedimento, forse non tanto convinto della bontà dello scultore lo farà accecare. Il Cristo velato è tra le più famose ed emozionanti opere scultore del patrimonio artistico mondiale, fu scolpita nel 1753 e seconda solo alla Pietà di Michelangelo o a quelle del Berini, mi viene a mente Apollo e Dafne. Nel Cristo velato traspare l’attimo ieratico e sacro in cui il corpo del cristo deposto dalla croce gli viene adagiata la Sindone. Il corpo è freddo, irrigidito da rigormortis.
L’espressività traspare con grande evidenza dalle pieghe del velo che copre le membra esanimi del Cristo. Al suo cospetto si riceve la sensazione di osservare il vero corpo di Cristo. Leggende o verità ci dicono che il Principe avesse consigliato di usare un corpo vero, su cui inserire la sua sostanza magica in modo che le stoffe, le carni si trasformassero in dura pietra, come il marmo “Calacatta” di Carrara il più puro, il più splendido e per questo preferito dai più grandi scultori.

Il velo, grazie alla perizia dello scultore attraverso la trasparenza cristallina, quasi a rendere inconsistente il peso del sudario, della Sindone, quasi a far percepire che fisicamente non c’è, eppure è lì visibile come se fosse stata creata da un artifizio dell’occhio. Il velo è creato dal corpo che piega il velo nel marmo con evanescenti onde. E’ grazie a questo miracoloso incantamento che la scultura diventa vera vita sublimata, trasformando il cadavere del Cristo in un sorprendente mistero. È una “visione” che lascia allo stesso tempo esterrefatti ma anche incantanti, frastornati da tale incanto di carne, ossa e stoffa che si fanno marmo.