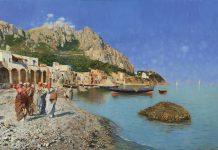[rating=5] A Palazzo Strozzi, fino al 20 luglio prossimo, è possibile ammirare due grandi Maestri del Cinquecento toscano: Pontormo e Rosso Fiorentino. Un confronto interessante tra due personalità, nate entrambe nel 1494. La mostra mette in luce i due artisti; l’accademico Pontormo (Jacopo Carucci da Pontormo) allievo e “costola” di Andrea del Sarto, come afferma il curatore Antonio Natali, e l’originale e individualista, seppur allievo dello stesso Maestro, Rosso Fiorentino (Giovan Battista di Jacopo).
Firenze e la Toscana sono, nel Quattro-Cinquecento, i laboratori, i centri di avanguardia, i palcoscenici, i centri culturali europei ed internazionali per tutte le arti, culle dell’Umanesimo e del Rinascimento. Pontormo e Rosso si fanno portavoci di quella diversa maniera di intendere l’arte, la “maniera moderna” del Cinquecento, e ne evidenziano le loro decise diversità, le loro scelte espressive, le loro divergenti vocazioni e le loro personali disposizioni culturali.
Entrambi iniziano il loro cammino nel 1509 a Firenze, nel Chiostro dei voti della Basilica della Santissima Annunziata, sotto la guida di Andrea del Sarto. Due gli affreschi realizzati: per Pontormo la Visitazione (1514-16), per Rosso l’Assunzione (1512).
La mostra si apre con queste due opere e, fin dall’inizio, balza agli occhi dell’osservatore quella diversa “via della maniera”. Pontormo, nella centralità del soggetto costituito da Maria ed Elisabetta che le si inginocchia davanti mentre, in alto, Abramo sta per sacrificare suo figlio Isacco, sembra strizzare l’occhio a Raffaello, sia per il maestoso sfondo architettonico, nel quale si avverte già un senso prospettico, sia per i panneggi delle vesti dai quali emergono, grazie ad abili giochi di luce, la sensualità dei corpi, dei volti, degli sguardi.
Rosso nella sua Assunzione ha un tratto più inquieto, più complesso, che traspare dal movimento vorticoso dei putti intorno alla Vergine, dal cielo del mondo celeste, così come dalle anatomie e dalle vesti degli Apostoli, solide e nette ma, allo stesso tempo, rudi e scabre. Un affresco che delinea marcatamente la separazione tra la sfera umana e terrena e quella divina.

Per il Convento della Santissima Annunziata, Pontormo realizza la Sacra Conversazione (1514); un fondale grigio neutro ospita Maria col piccolo Gesù al centro, Santa Lucia, che mostra alla Vergine il piatto con gli occhi, San Michele, che le presenta la bilancia per pesare le anime degli uomini nel giorno del Giudizio Universale, due Santi genuflessi ai lati della Vergine. Un prezioso gioco di sguardi, ora vivaci tra i personaggi ora estatici verso l’Alto, sono la base del lavoro pontormiano, completato dai colori vivi e primari delle vesti e dei loro panneggi, in una sorprendente torsione di corpi resa attraverso l’uso di chiaroscuri.
Un evidente omaggio ai Medici è la pontormiana tempera su tela titolata Due guerrieri con lance (1513), un lavoro veloce, uno schizzo pittorico forse base di più impegnativi apparati di feste cittadine o cortei che richiama alla memoria i due lavori scultorei di Michelangelo per la Sagrestia Nuova delle Cappelle Medicee di San Lorenzo per le tombe di Giuliano de’ Medici Duca di Nemours e Lorenzo de’ Medici Duca di Urbino, recentemente valorizzate dagli scatti fotografici di Aurelio Amendola.
Ancora un confronto meritano la Pala Pucci (1518) del Pontormo e la Pala dello Spedalingo (1518) del Rosso. In entrambe domina la libertà espressiva ma, mentre in Pontormo, come sottolineato dal Vasari, domina la “tanta bella maniera”, il “colorito vivo”, la meraviglia michelangiolesca nella resa di panneggi e dell’armonia della tavola che ha il suo fulcro in San Giuseppe, nel Bambino e in San Giovanni Evangelista, così come nell’architettura antica della nicchia che esalta la Vergine, in Rosso non ci sono sfondi ma si contrappongono e sovrappongono i corpi, come nei pulpiti di Donatello. I colori sono più cupi, la tensione è più marcata, più netto è il contrasto tra vita e morte. Sorprendente, in entrambi, la cura per il dettaglio: la verosimile lunga barba mossa dal vento di San Giovanni, i riccioli d’oro dei bambini, i fiori e le erbe che circondano i piedi di San Giovannino nella Pala del Pontormo; la magrezza, quasi scheletrica, di San Girolamo, i veli delle vesti del Bambino, la lunga chioma rossa di San Giovanni Battista per la Pala del Rosso.

Della Galleria Palatina di Palazzo Pitti la mostra ospita la pontormiana Adorazione dei magi (1519-20). Al di là della varietà delle figure umane, del soggetto sacro e delle varie fogge, risulta sorprendente l’attenzione dell’artista verso il naturalismo del paesaggio, dalla vegetazione alle nubi di polvere che si estendono alle verdi colline, offuscandone la nitidezza e facendone uscire, a poco a poco, in una sovrapposizione di piani, i cavalieri a cavallo. Un paesaggio che per la precisione di resa richiama la lezione leonardiana e quella delle stampe nordiche di Albrecht Dürer.
Forza e prontezza, sensualità e dolcezza contrastano nell’Angiolino musicante (1521) del Rosso. Da un fondale nero, pronto e immediato, si impone allo sguardo dell’osservatore la dolcezza dell’Angelo. Il carattere sognante del putto, appoggiato al liuto, emerge dallo sfondo in tutta la sua potenza; la musicalità sembra uscire dall’armonia dei colori e dall’intimità pensante dell’Angelo.
Della sezione dedicata ai ritratti meritano di essere ricordati quello di Cosimo il Vecchio (1518-19) del Pontormo e quello dell’Uomo con elmo (1523-24) del Rosso. Cosimo il Vecchio esce dalla tavola, un ritratto vivo, del quale è quasi possibile toccarne le vesti di panno rosso, forse un velluto, valorizzato dai giochi di luce; così come il tralcio d’alloro e il motto del cartiglio intrecciato tra le fronde che indica l’immediata successione all’albero vecchio di uno nuovo, alias Lorenzo il Magnifico. Fieri i tratti del volto, di profilo, con lo sguardo triste seppur proiettato verso quell’imminente futuro di speranza.

Il Ritratto di un uomo con elmo è l’unico che porta la firma dell’autore RVBEUS FACIEBAT. L’uomo, seduto, a mezzo busto, è vestito in abiti scuri. Lo sfondo è uniforme. Escono in risalto il prezioso collo e il polsino bianco della camicia, così come l’elmo curato fin nei minimi dettagli, dalle tre piume alla luce che riflette sulla visiera, alla fodera interna di colore rosso vivo e brillante.
Dai ritratti ai disegni. In questa sezione il confronto tra i due artisti sembra ribaltarsi. La precisione e la definizione dei soggetti delle tele pontormiane, gli sfumati e le inquiete e vorticose rese pittoriche del Rosso sembrano, qui, contrapporsi. L’uno sembra diventare l’altro. Gli abbozzi e gli sfumati realizzati a pietra nera o a pietra rossa dal Pontormo trovano il suo perfetto contrario nei disegni vivaci, pronti, precisi e definiti del Rosso.
I soggetti ritratti sono tutti nudi accademici e seguono la scuola del “naturale” inaugurata da Leonardo e da Michelangelo. Per entrambi gli artisti i nudi rispondono a quell’ideale di bellezza, di ricerca della perfezione, di armonia delle parti del corpo umano e della sua plasticità, perseguito dallo stile naturalista fiorentino del Rinascimento.
L’attenzione, però, cade sui lavori del Rosso, sulla sua costante ricerca della tensione del corpo attraverso il realismo e l’espressionismo, come nella Madonna col Bambino e i santi (1519-20), lo Studio di nudo per il san Sebastiano della Pala Dei (1522 ca.), la Vergine annunciata (1524-25 ca), e lo Studio di nudo per il Cristo della Deposizione di Sansepolcro (1527), quest’ultimo base per la tavola Deposizione della croce del 1527-28.
Ultima opera realizzata in Italia dal Rosso, prima del suo trasferimento in Francia, a Fontainebleu, è la tela Morte di Cleopatra (1525-27). Siamo di fronte ad un nuovo Rosso, intimo, sensuale, influenzato dall’ideale della bellezza femminile greca, così come da quella michelangiolesca, così come da quella fiamminga. Rosso torna all’antico. Cleopatra occupa trasversalmente la tela, dominandola col suo corpo inondato dalla luce. Il capo è reclinato all’indietro e poggia sul braccio sinistro attorno al quale è attorcigliato l’aspide fatale che l’ha morsa. Il braccio, a sua volta, poggia sul drappo rosso, sul cuscino e, poi, sul divano, sorretto da una maschera d’oro e, sotto questa, da un volto in ombra che ci appare con un’espressione di terrore, quasi stesse urlando. Alla perfezione della resa dell’aspide si affianca quella di un piccolo orecchino con la perla illuminata da una luce intensa, monile che cattura lo sguardo dell’osservatore, così come quello della successiva Ragazza con l’orecchino di perla (1665-66) di Jan Vermeer.

All’attività di pittore Rosso ha, da sempre, affiancato quella di disegnatore di stampe. Una produzione parallela ma non meno preziosa di quella pittorica. Già Vasari, nelle Vite, aveva messo in luce le capacità grafiche del Rosso, sottolineando che per il Baviera, l’editore che aveva stampato i disegni di Raffaello, il Rosso aveva fatto «in disegni di stampe tutti gli Dei, intagliati poi da Gian Giacomo Caraglio alcune, quando Saturno si muta in cavallo e quando Plutone rapisce Proserpina».
La mostra ce ne offre molti, a testimonianza del fatto che questa tipologia d’arte – che trova fondamento nelle stampe di Albrecht Dürer – era molto in voga all’epoca ed era un prezioso mezzo per far circolare le proprie invenzioni artistiche nel mondo contemporaneo.
Balzano in primo piano la ricchezza d’invenzione associata ora alla grazia e alla meraviglia, ora alla forza e alla brutalità, elementi che si sprigionano dai soggetti rappresentati. A visioni poetiche e contemplative si contrappongono disegni di stampe dinamici, vitali e, a volte, quasi diabolici. Alla prima tipologia è possibile ascrivere molte delle incisioni degli Dei nelle nicchie, alla seconda il ciclo delle Fatiche di Ercole, in special modo Ercole e Cerbero, Ercole e i Centauri, e la sorprendente Furia (1524). in quest’ultima l’orrenda figura scheletrica in primo piano è sospinta dal vento – richiamo infernale dantesco – e sembra anticipare la Medusa del Caravaggio. Gli occhi allucinati e sbarrati, la tensione del volto la fronte corrugata, la bocca spalancata che mostra tutti i denti esaltata dalla luce che ne evidenzia i dettagli, sono inseriti in un fondale popolato di mostri di ogni sorta ai quali la Furia si lega. Una serpe le avvinghia il braccio con straordinaria potenza, quel braccio che sorregge un teschio simbolo della caducità di tutte le cose terrene e del tempo che corrompe la bellezza, portando in primo piano questo corpo terrifico che richiama l’idea della morte.

A chiusura della mostra ancora Pontormo con la sua Visitazione (1528-29 ca.). Un quartetto femminile, con vesti dai colori accesi e dai panneggi increspati che ne evidenziano le diverse silhouette, è al centro della tela, sembra quasi una danza, un rondeau. L’opera è innovativa per l’epoca perché sono scardinati tutti i principi prospettici contemporanei. Le donne sono poste in primo piano su un fondale quasi metafisico alla De Chirico, le architetture fiorentine sulle sfondo, così come i personaggi e l’asino che, incuriositi, osservano l’incontro come delle miniature. Pur essendo un quartetto, le figure dinamiche della scena sono due, quelle con l’aureola, Maria ed Elisabetta, la giovinezza e la dolce vecchiaia. Le altre due donne, statiche, altro non sono che le controfigure delle due protagoniste, inquiete “ombre a colori” che sembrano racchiudere quel vuoto lasciato dal corpo per caricarsi di quella forza di presenza che diventa il corpo dell’anima, come sostenuto da Pierre Restany.
La mostra ci permette di conoscere e apprezzare le opere di due grandi ingegni fiorentini che, abbandonando lo studio della natura e la semplice imitazione dal vero, hanno saputo scrivere una nuova pagina della Storia dell’Arte, portando in scena, sui palcoscenici della Firenze del Quattro-Cinquecento quelle nuove e divergenti “vie della maniera”.