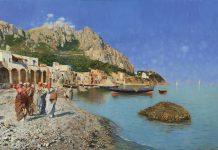Nella prima parte dell’articolo ci eravamo lasciati con il fiato sospeso alla ricerca di nuove spiegazioni e la descrizione di questa enigmatica rappresentazione, qui di seguito riportiamo la prosecuzione di questo affascinante viaggio nella Basilica più bella di Perugia e tra le più particolari d’Italia.
San Benedetto, rappresentato in nero e collocato al centro del dipinto diventa lo spazio, ormai scheletrico, dove era collocato il naso della immonda bestia. San Pietro e San Paolo, collocati ai lati estremi del dipinto, assumono la forma delle orecchie aguzze del mostro.
In alto altre figure di sacerdoti, si tramutano nelle corna di un diavolo. I giochi di luce e le ombre insieme alle posture dei chierici vanno a delineare il volto del demone con lo sguardo e gli occhi di fuoco. L’allusione al principe degli inferi e chiara anche osservando un altro aspetto: nelle orbite oculari vicino alle pupille rappresentate dal Sole e della Luna, si nota la luce del pianeta Venere, denominata anche la stella della sera perché è la prima che si vede sopra l’orizzonte, ma anche quella del mattino perché è l’ultima a scomparire. Il pianeta Venere è per questo un corpo celeste che dona la luce. E proprio Lucifero è il nome dell’angelo che precipita dal Cielo dopo la cacciata da parte di Dio e che la tradizione giudaico-cristiana dà al diavolo, cioè colui che porta la luce. Perché un pittore, soprattutto in un periodo così oscuro come quello dell’inquisizione, ha voluto rappresentare il male tra le navate di una basilica cattolica? In un’opera così grande e in modo cosi palese raffigura il diavolo?
Il pittore nacque nell’isola greca di Milos. In tenera età la sua famiglia si trasferì a Venezia, dopo di che il suo nome si tramutò da Vasilakis a Vassilacchi ma è con il nome dell’Aliense, lo straniero che si fa conoscere ed apprezzare. Lavorò alla bottega di Paolo Veronese, amico e poi rivale del Tintoretto. I committenti religiosi ed i notabili della Serenissima facevano a gara per assicurarsi contratti con l’artista, considerato come pittore serio nel lavoro e dal carattere mansueto. I suoi affreschi nel palazzo Ducale si trovano in quasi tutte le sale. L’Aliense si sposò per tre volte, dalle tre mogli ebbe due figlie che furono orientate verso la vita monastica divenendo suore.

Grazie ai monaci benedettini di San Giorgio Maggiore di Venezia, l’artista venne caldamente raccomandato ai confratelli della città umbra di Perugia, proprio negli anni in cui si stava lavorando al tempio dedicato a San Pietro. Ed a Perugia l’Aliese dipinse anche la vita di Cristo seguendo con scrupolo quanto descritto nel Vecchio Testamento attraverso dieci grandi tele, collocate, cinque per parte, ai lati della navata centrale di San Pietro.
Lo stile della grande tela raffigurante l’Apoteosi dell’ordine dei Benedettini, che terminò a tempi di record in soli 13 mesi, sembra essere molto più vicino al nuovo clima introdotto dopo il concilio di Trento dal 1545 al 1563 che dà vita ad un periodo denominato controriforma epoca storica, culturale ed in cui la Chiesa Cattolica mise in atto una serie di disposizioni disciplinari, teologiche e culturali volte a radicare l’ortodossia religiosa contro le novità realizzate dal protestantesimo.
Ed è proprio la pittura ad assumere un valore educativo e per questo si imponeva all’arte pittorica una visione più cupa, più sacrale rispetto al gioioso “rinascimento veneziano” dei Veronese e dei Tintoretto che l’Aliense ben conosceva.
Per completare l’opera pittorica si deve ampliare la visione prospettica e fare anche uno sforzo con la mente e la fantasia. Infatti è necessario osservare il portale ligneo della basilica che sembra completare l’opera dell’Aliense e dare una mano all’osservatore a chiarire una parte del mistero.
Il portale che è l’ingresso di San Pietro si trova alla base della gigantesca tela, nella rappresentazione dell’artista questa vuole assumere la grande bocca del demone, del male che fagocita coloro che lasciano la basilica, la chiesa riformata per tornare alla vita di tutti i giorni privi della fede e, se seguita in modo corretto porta alla vita eterna dei cieli, mentre al contrario porta verso il male.

Il diavolo è in agguato, in ogni momento nella vita quotidiana ed è anche nel seno della Chiesa stessa. Proprio per la mancanza dell’unità spirituale che la riforma attuata dal Lutero aveva ormai irrimediabilmente minato, eresia che bisogna contrastare, con ogni mezzo soprattutto ricordando ai fedeli di seguire la parola di Dio e la regola Cattolica.
In alto della tela c’è una scritta in latino forse fatta scrivere da un dottissimo frate benedettino che all’epoca frequentava Perugia e che si chiamava Arnold Wyon e che dice: “Mittam tibi adiutorium”, questo è un passo biblico del quarto libro di Esdras, dove Dio si rivolge al popolo eletto d’ Israele dicendo: “Io ti manderò in aiuto i miei servi Isaia e Geremia…”.
Il monaco Wyon è passato alla storia per aver reso nota per la prima volta, nel suo testo “Lignum vitae”, la famosa “Profezia di Malachia”.
La profezia di Malachia è un criptico elenco di 112 motti in latino, nel quale vengono descritti tutti i papi e gli antipapi da Celestino II (eletto nel 1143) fino all’ultimo pontefice che, secondo la profezia, si chiamerà “Petrus Romanus” ultimo papa che porterà alla distruzione del papato ed alla distruzione di Roma.
Lo scritto però è con molta probabilità un clamoroso falso, infatti secondo alcuni studiosi questo fu realizzato durante il conclave del 1590 per favorire l’elezione al soglio pontificio del cardinale Girolamo Simoncelli, lavoro che però si rivelò vano in quanto fu scelto un altro papa, Gregorio XIV il papa che scomunicò il Re di Francia Enrico IV dichiarandolo un eretico e un persecutore della Chiesa. L’autore del testo fu con molta probabilità Alfonso Ceccarelli, passato alle cronache per essere il più famoso falsario italiano del Cinquecento, abilissimo alteratore di pergamene, libri, codici ed alberi genealogici e per questa sua pratica condannato e decapitato nel giugno del 1583.
L’arte e gli artisti sono stati impiegati come diffusori di messaggi per secoli, cosi che mi viene da pensare come l’arte sia la prima forma di marketing, proprio per il suo altissimo valore simbolico sviluppata come finissima arma nelle mani di organizzazioni, religioni e di uomini potenti che hanno usato l’arte e gli artisti per diffondere le loro idee ed i loro messaggi.