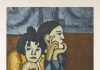L’Adorazione dei Magi 1481. Uffizi, Firenze.
Realizzata dal 1481 al 1482 risulta essere molto particolare ed estremamente innovativa se confrontata con altre “Epifanie” coeve o contemporanee a questa di Leonardo.
E’ tra le opere più affascinanti dell’arte, fascino dettato anche dall’aspetto del non finito, del non terminato. Sappiamo benissimo che quando una cosa, in questo caso un’opera artistica, è lasciata incompiuta fa viaggiare la fantasia dell’osservatore che cerca di finire quella incompiutezza attraverso il proprio grado di conoscenza dell’argomento rappresentato e soprattutto attraverso la propria fantasia.
La Sacra Famiglia si trova al centro della composizione, assumendo il ruolo principale dell’opera, con la Madonna che tiene sulle ginocchia Gesù bambino, San Giuseppe può essere riconosciuto con il personaggio barbuto che si trova dietro alla vergine, quasi seminascosto.
Intorno al Bambino ed alla Madonna ruotano un insieme di personaggi anonimi che appaiono quasi disinteressati a quello che sta accadendo cioè alla nascita del Messia. Le figure dei Re Magi sono facilmente assimilabili a quelle dei contadini con cui si confondono. Due di essi si riconosco perché con se hanno i doni, l’incesso e la mirra mentre il terzo è soltanto inginocchiato cosa che lo rende anonimo.
Gesù è raffigurato mentre cerca di prendere un recipiente che è differente dallo scrigno che nella iconografia viene usato per rappresentare il dono dell’oro e che indica la regalità spirituale.
Nella parte posteriore alla scena precedente descritta si possono vedere delle rovine e dei cavalieri che si azzuffano non curanti del miracolo che si sta compiendo. Leonardo raffigura non i pastori che recano omaggio al Re dei re ma rappresenta una folla di personaggi sopresi quasi sconvolti dagli eventi che si stanno compiendo sotto i loro occhi. Invece di celebrare la gloria del Signore, si mostrano assorti nei loro pensieri come se non capissero quello che in quell’istante accade, come se si trattasse di un evento enigmatico.
Sulle rocce dietro la Madonna si vede una pianta di Carube, pianta usata da San Giovanni Battista per nutrirsi quado si trovava nel deserto e per questa associata al santo. Dietro alla pianta è presente una figura che tiene il braccio destro alzato e con la mano tiene il dito alzato, segno giovannita che nel linguaggio dei simboli rappresenta il potere.
Secondo alcuni critici tra gli astanti ci sarebbe l’autoritratto di Leonardo, visibile nella figura del giovane in basso, dove si può notare una certa somiglianza con il ritratto di Leonardo, quello visibile nell’adorazione dei Magi del Botticelli soprattutto per le vesti e la stessa torsione della testa.
L’Adorazione del da Vinci risulta molto complessa da decodificare e collocare nella interpretazione dei dettami della chiesa rinascimentale ed è ricco di elementi assai enigmatici.

Gesù e San Giovannino. 1483-1485 collezione privata.
Si tratta di una piccola tavola ad olio con il soggetto ispirato dai vangeli apocrifi dove viene narrato che Gesù durante la fuga in Egitto per sfuggire dalle persecuzioni di Erode incontra nel deserto San Giovannino.
Nei vangeli si narra di come i due si fossero dedicati a studi di carattere ermetico, alla corte dei faraoni d’Egitto.
I due bambini sono rappresentati mentre si scambiano un abbraccio ed un bacio affettuoso.
Il bacio simboleggia un percorso iniziatico, usato da moltissime confraternite dai Templari ai Massoni e identifica il passaggio, la trasmissione del segreto oppure del sapere.
Secondo alcuni studiosi sarebbe ad indicare invece il futuro “tradimento“ del cugino di Gesù rimasto fedele alla religione ascetica essena.
Nella prossima puntata: la Vergine delle Rocce e l’Ultima cena.






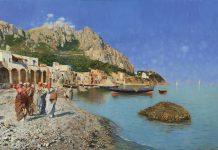






![Ukiyoe, il mondo fluttuante: visioni dal Giappone Utagawa Kuniyoshi I tre vassalli [di Yorimitsu] Shumenosuke Sakata no Kintoki, Usui no Sadamitsu, Genji no Tsuna e demoni 1861 Silografia policroma, trittico](https://www.fermataspettacolo.it/wp-content/uploads/2024/03/Ukoyeok-100x70.jpg)