
Un cupo viola ad opprimere la luce, nell’aprirsi del sipario, vela la scena: una stanza grande, angolo di boiserie che fa tutt’uno con ampi e altissimi scaffali, due porte praticabili sul fondo, cornici cieche di miniature e quadretti come ricordi impediti e vuoti, al centro un uomo su una sedia. Di fronte a lui una donna e intuiamo che i fogli che l’uomo legge son le lettere della donna, della moglie, della moglie tradita. L’uomo ha appena lasciato la famiglia, ma la grande casa alle spalle – lo comprenderemo solo più tardi, ricomponendo i frammenti come filologi del dolore – non c’è ancora, non è ancora nemmeno un pensiero, sarà la casa dei legami nudi e freddi, il prezzo dell’ordine (ri)conquistato, bella placida serena come un sepolcro imbiancato, alta turrita inviolabile come una cittadella. È la prima scena della nuova pièce che Domenico Starnone ha tratto dal suo romanzo, Lacci: la vediamo qui al Bellini a Napoli, per la regia di Armando Pugliese, Silvio Orlando è l’uomo seduto in ombra, Vanessa Scalera, la moglie tradita, “dice” la lettera, e poi un’altra e un’altra ancora. Un lungo prologo epistolare. Perché l’autore decide di dare a questa tragedia – di ciò si tratta, con i protagonisti presi nella spirale che li conduce inevitabilmente alla rovina, al di là delle volontà loro – una forma molto particolare, che il regista paragona a una sinfonia, ma che ha comunque di certo una struttura complessa: individuiamo sicuramente tre parti, pure perché situate in tempi diversi, e che l’autore sceglie, anche dal punto di vista formale, di rendere in differenti modalità; la seconda parte, centrale e più lunga, a ben vedere può poi a sua volta esser tripartita, ottenendo in tutto cinque parti, ben diverse tra loro: cinque movimenti d’una sinfonia mahleriana, cinque parti d’una tragedia classica, in ogni caso cinque modalità di rapportarsi con un’esperienza che è diventata talmente centrale nella vita dei protagonisti, da segnarli per la vita, da condizionare, nel bene e nel male, tutte le scelte future, tutta la propria esistenza. Questo episodio – il protagonista tradisce, va via di casa per quattro anni con un’altra, poi torna ristabilendo in apparenza l’ordine precedente – viene raccontato, vissuto e rivissuto, in una specie di moderno rashomon, dai diversi punti di vista dei protagonisti, che evidentemente differiscono alquanto tra loro, narrazioni parallele che sorprendentemente convivono e coesistono pur divergendo tra loro.

La prima parte è dunque un prologo a tutti gli effetti: stabilisce i termini della questione, ci catapulta in medias res, è costruito in forma epistolare ma a senso unico, attraverso le lettere che la moglie, Vanda, non avendo altro modo di comunicare col marito, Aldo, gli scrive. Come sono le lettere di una moglie tradita, e tradita per una donna molto più giovane (anche più bella, si dirà poi)? Sono quelle che possono essere, oscillando tra invettiva e preghiera, querimonia e rimpianto allarmato: lettere che coprono tutto il periodo in cui Aldo cambia città, va via da Napoli, trova sistemazione provvisoria a Roma a casa della ragazza, vede saltuariamente i figli, acconsente senza batter ciglio a che i figli stessi vengano affidati alla madre, assiste, tenendosi ben lontano, al tentativo di suicidio della moglie, finché, senza un motivo preciso, senza un vero perché, senza sentire il bisogno di spiegarlo nemmeno a se stesso, chiede a Vanda di rivedere i figli da solo: sono passati quattro anni. Durante tutto il lungo, lunghissimo monologo delle lettere, una dopo l’altra, di Vanda, Aldo siede al centro della scena, sottolineando i momenti più pungenti con una smorfia, un’alzata di spalle, un moto d’impazienza. Ma in silenzio, lasciando cadere a terra le lettere man man che vengono lette. Perché questo è, evidentemente, il punto di vista di Vanda, i suoi vissuti, i suoi ricordi.
La seconda parte ci sbalza in avanti di molti anni, e siamo, lo comprendiamo subito, nella casa romana – ora esiste sul serio – di Vanda e Aldo, ne ricostruiamo a ritroso la storia, attraverso brandelli di ricordi, emozioni rivissute, dolori mai spenti: è dopo l’incontro con i figli, dopo che Anna, la figlia di nove anni, avrà “verificato” che padre e fratello Sandro hanno lo stesso modo d’allacciarsi le scarpe – particolare trascurabile, perlomeno agli occhi di Aldo e della sua superficialità, ma che è probabilmente l’intero lascito del padre ai figli – che Aldo deciderà di tornare a casa, dapprima per qualche giorno, poi più spesso, alla fine definitivamente. La riconciliazione avrà per pegno la grande casa romana, che è un po’ come il Walhalla per Wotan, segno, espressione di un ben preciso status ma anche splendida prigione dorata dove Vanda chiuderà a chiave, infine, i propri sogni e quelli del marito e perfino quelli dei figli, nel culto rigoroso d’ossessionato ma imperfetto ordine: la casa diventa la vera protagonista del racconto, metafora della famiglia, certo, coi suoi disastri e le sue rovine, del Paese, forse, con l’incapacità dei padri di sopperire alla mancanza d’amore e di sogni se non con una casa bellissima ma dalle cornici cieche, dai profondi scaffali che sembrano alte torri merlate sui cui riposano, ben ordinati, bellissimi libri grigi e anonimi: regno di Labes, sornione gatto di famiglia che Aldo spiegherà prender nome dall’abbreviazione di “labestia”, la bestia di casa, ma che si scoprirà molto probabilmente essere invece – e Aldo ne aveva rimosso il vero, doloroso significato – di derivazione latina, labes come rovina e sventura. Casa sventurata e pericolante tenuta insieme dalla sopportazione e dall’abitudine, che, all’inizio della seconda parte, i due coniugi ormai alle soglie delle vecchiaia, rientrando da un viaggio, trovano violata, in completo (dis)ordine causato da probabili ladri, l’eredità del passato messa a nudo, come le lettere che, tanti anni dopo, riemergono a rivendicare uno spazio che non è solo memoria ma dolore, ancora vivo e presente.

Le ritrova, Aldo, tra le carte e i libri rovesciati sul pavimento e rinnovano il dolore d’allora ma, pure – ecco la sua versione – il non troppo celato rancore verso la moglie che ha voluto dimostrargli di non poter esser padre se non attraverso di lei, e che escludendola tagliava fuori definitivamente pure i figli. È un lungo monologo, che occupa il centro di questa seconda parte, travestito da dialogo coll’anziano vicino (Roberto Nobile), in cui vediamo la realtà – sempre riferita al momento centrale della vita di questa famiglia – secondo il punto di vista di Aldo. È preceduto, questa rhèsis, da uno Scherzo più leggero, affastellarsi di luoghi comuni, stereotipie e frasi fatte, riferite al tempo atmosferico, alla filosofia dei furti in città, agli zingari, al non dar confidenza agli estranei, a tutta la spazzatura mentale e psicologica, insomma, su cui si regge la nostra vita e che tiene in piedi, ancora, la casa, nonostante le ben visibili crepe, nonostante non ci sia più neppure l’apparenza di famiglia felice dovuta a figli piccoli: se ne sono andati, ormai, Anna e Sandro, anzi sono in rotta per via d’un’eredità di famiglia. La preoccupazione di Aldo, però, è tutta nel timore che nel caos della casa ormai in disordine – è sparito pure Labes – Vanda possa ritrovare vecchie foto gelosamente conservate per tutti questi anni: le foto di lei, la giovane amante nel fulgore della sua bellezza, stipate e nascoste nell’unico oggetto colorato della stanza candida e grigia, un cubo blu, sul più alto (e più in vista) degli scaffali, che nasconde un meccanismo a molla. Qualcuno – i ladri? – ha trovato le foto, fantasie di ricatto inseguono la paura che la moglie possa ritrovarle, scoprire dopo tutti questi anni la persistenza d’un sentimento, sopravvissuto alla sterilizzazione delle emozioni. L’ultima porzione di questa parte centrale è occupato dal dialogo tra i coniugi, che chiarisce in modo definitivo ciò che s’era intuito: il ritorno a casa di Aldo, anni prima, ha rimesso insieme il matrimonio, ha creato questa casa come baluardo contro le insidie dell’istituzione, non ne ha ritrovato però i motivi fondanti, l’amore non ha mai abitato queste stanze: a ogni occasione – dice Vanda – avrei potuto avere un amore: è come la pioggia, una goccia urta a caso contro un’altra goccia, si forma un rigagnolo. Basterebbe insistere nella curiosità iniziale, e la curiosità diventerebbe attrazione, l’attrazione crescerebbe fino a indurre al sesso, il sesso imporrebbe la ripetizione, la ripetizione fonderebbe una necessità e un’abitudine. Ecco.
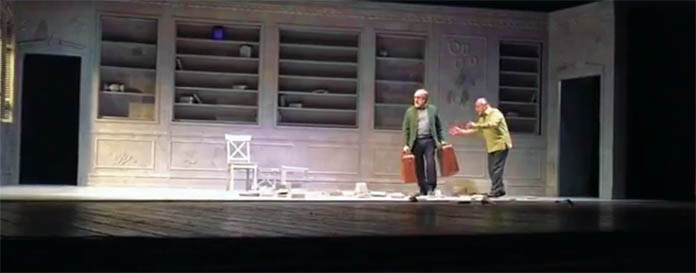
E se il sonno della ragione genera mostri, non è da meno il sonno dell’amore: entra nei rapporti con gli altri, raggela i cuori, anestetizza gli affetti, crea l’inferno dell’abitudine e dell’assuefazione, “l’inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme… di cui diventiamo parte fino al punto di non vederlo più”: se il matrimonio è diventato mera istituzione repressiva che ha intrappolato per la vita i protagonisti della vicenda, stringendoli in lacci soffocanti, per i figli ne ha determinato la formazione: se in Anna (Maria Laura Rondanini), che non vuole aver figli per paura di far loro ripercorrere il calvario loro, l’inferno sterilizza gli slanci e i sentimenti, in Sandro (Sergio Romano), mostra come si possa ripercorrere le orme dei padri, nell’eterna fanciullaggine delle non scelte, avendo tre famiglie e non rinnegandone nessuna. Saranno loro, i figli, a chiudere la casa e a (progettare di) venderla, a gettarla nel caos, a metter, probabilmente, la parola fine a ciò che rimaneva ancora in piedi del posticcio matrimonio che li ha generati, perché i nostri genitori – dicono – ci hanno rovinati. Si sono insediati nelle nostre teste, qualsiasi cosa diciamo o facciamo continuiamo a obbedire a loro. Un Götterdämmerung in piena regola, quello che s’annuncia nella casa della sventura. Il teatro di qualità – come si vede – è tutto qua: un testo ottimo, una regia attenta, un capocomico coi fiocchi, attori appassionati e convinti: non so se sia molto o poco, so che sono gli ingredienti giusti perché il teatro non muoia.














