
[rating=2] La mostra “Picasso e la modernità spagnola”, in scena a Palazzo Strozzi di Firenze fino al 25 gennaio 2015, propone al pubblico un potpourri di opere, non molte di Pablo Picasso (1881-1973), provenienti dal Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia.
Il percorso si apre e si chiude con due versioni picassiane de Il pittore e la modella, entrambe del 1963. Picasso affronta questo tema nelle sue varie interpretazioni: ora come momento della creazione, in un’attenta analisi del rapporto pittore-modella, ora come omaggio alla ritrattistica, quasi un confronto con i grandi maestri ottocenteschi. I due protagonisti sono sempre divisi dal cavalletto, quel cavalletto sul quale poggiano le tele nelle quali si percepisce un qualcosa di misterioso, di cangiante, una realtà che ben descrive il corpo umano, non tanto nella sua delineata esteriorità, quanto nei suoi moti dell’animo.
Dalla pittura, seppur versatile e dai colori violenti e contrastanti che dai blu arrivano ai verdi passando per i gialli, gli aranci, i rossi, si arriva alla scomposizione cubista. Inizia con Testa di donna (Fernande) del 1910 la prima sezione della mostra, dal titolo “Variazioni”. Nelle opere proposte le variazioni sono iconografiche ma, soprattutto, stilistiche. La prima creazione è quella che rappresenta la sua compagna e modella Fernande Olivier. Il suo volto è decomposto in diverse sezioni di piano che vanno ad esaltarne gli elementi costitutivi: dagli occhi, al naso, alla capigliatura che si stagliano sullo sfondo, uscendo da esso e divenendo tridimensionali.
Di tutt’altro genere la tela Busto e tavolozza del 1925. Sembra quasi di imbattersi in un dipinto di De Chirico, sia per la scelta dei colori sia per la collocazione fisica degli elementi della natura morta presenti nella creazione. Interessanti i contrasti bianco/neri proposti nel volto; Picasso riflette pittoricamente sul concetto di doppio. Questo raddoppiarsi della realtà, nato dal contrasto, che permette, pur inizialmente confondendo lo spettatore, di cogliere ogni più profondo aspetto di quella stessa realtà portata sulla tela. Quel dualismo che già in Jung, Freud e Rank è la base dell’Io.
Scomposizione ed esaltazione della bellezza sensuale sono gli elementi fondanti dell’acquaforte Donna nuda seduta con la testa appoggiata sulla mano, del 1924, e della sua trasposizione pittorica, con variazioni, nella tela Donna seduta appoggiata sui gomiti, del 1929. Linee morbide, sinuose e geometriche si fondono in un unicum, creando una/due figure armoniche.

Nella tela, oltre la sinuosità del corpo, dal tratto e dai colori solo abbozzati, è interessante leggere la rappresentazione di due volti: quelli delle amanti picassiane del momento, Marie-Thérèse Walter e Dora Maar. Ad una prima osservazione, in primo piano emerge il volto della donna dai capelli biondi e dal cappello bicolore azzurro-viola e rosso, geometricamente scomposto in triangoli e quadrilateri dai tratti neri; ma, ad uno sguardo più attento, l’occhio più basso dà vita ad un secondo volto femminile, quello di una donna-giaguaro, forse Dora Maar, dalla capigliatura nera che scende fin sul petto e dai tratti ben definiti, molto più compiuta rispetto al volto in primo piano, la reale Donna appoggiata sui gomiti che dà il titolo all’opera.
Alla fotografa dei Surrealisti, Picasso, nel 1939, dedica il Ritratto di Dora Maar nel quale abbandona la scomposizione cubista e la conseguente compenetrazione simultanea dei piani, per valorizzare il volto, ora rosato ora giallo, dai lineamenti marcati che ne sottolineano i cambiamenti emotivi. Volto chiaro che si staglia, per contrasto, dalla capigliatura nero-bordò e dalle geometriche vesti rosso nere.
Della sezione “Realtà e Sopra-Realtà” merita menzione lo schizzo di Salvator Dalì (1904-1989) titolato Schizzo per “L’uomo invisibile” del 1930, realizzato con matita, matita colorata e inchiostro. Ancora un gioco di doppi, in preparazione di quel dipinto rimasto incompiuto, ma rivelatore di quella doppia dimensione conscio/inconscio che sta alla base della poetica artistica dell’autore spagnolo.
Senza dubbio, le sezioni più interessanti e meritevoli di nota sono quelle che portano titolo “Verso Guernica: il Mostro e la Tragedia” e “Verso Guernica: la Tragedia” nelle quali possiamo ripercorrere gli studi, i disegni preparatori, i dipinti, le incisioni dedicate al Minotauro, il Mostro che prelude a Guernica, e alla realizzazione del capolavoro.
Picasso sceglie, nella Minotauromachia, una delle figure più arcaiche ed emblematiche della mitologia greca, quel Mostro metà uomo, metà toro. Torna, nuovamente, quel doppio, quell’unione di mito e realtà, di fusione tra autore e Mostro, tra umano e ferino, quella commistione di Minotauromachia e Tauromachia, quell’unione mitica Minotauro-Giovenca, specchio dell’esistenza picassiana. Quel Mostro feroce, dominato dall’istinto animale, che per la sua violenza anche Dante colloca nel Canto XII dell’Inferno, a guardia di quel Cerchio di peccatori che hanno perso la ragione cedendo all’istinto, alla bestialità inconsapevole della mente umana, quella “matta bestialità” che, però, fa di Picasso l’artista unico e geniale che conosciamo.
Nella prima serie di acqueforti che esaltano la potenza animale del Minotauro e la sua sconfitta davanti a Teseo (tutte realizzate nel 1933) possiamo, adesso, leggere una profetica visione degli eventi futuri della storia spagnola a lui contemporanea. Le opere di questa sezione appartengono alla Suite Vollard, una sorta di “romanzo” storico sul Minotauro. Come già osservato da Gérard-George Lemaire, questo Mostro è alcune volte rappresentato con un viso umanizzato, altre infuriato; talvolta omicida, altre cieco e vinto; ora trionfante e implacabile, ora quasi degno di pietà guidato, ormai cieco, da una bambina in quell’oscurità decadente. Quell’oscurità che pone il Re toro davanti alla morte, alla finitezza dell’essere, staccandolo dal suo contesto fantastico e mitologico e calandolo, a pieno, nella Spagna degli anni ’30.
La seconda sezione di tele e disegni è realizzata tra il maggio e l’ottobre del 1937 ed è la continuazione tematica della precedente. La Minotauromachia scende a servizio di Guernica, opera commisionatagli dal governo repubblicano di Spagna per la sala del padiglione spagnolo all’Esposizione Internazionale delle Arti e Tecniche di Parigi. Picasso porta in scena il bombardamento della città basca di Guernica, rasa al suolo dall’aviazione del terzo Reich, il 26 aprile 1937.
Ed eccoci difronte alla tela Testa di cavallo. Schizzo per “Guernica”, un solo elemento ma già intensamente drammatico, collocato centralmente nell’opera finale, espressione di quel disperato grido del popolo spagnolo, che trova corrispondenza nel secondo disegno, a matita, Cavallo e madre con il figlio morto. Schizzo per “Guernica”. Due soggetti affiancati nel disegno, uniti nel dolore e nella sofferenza della tragedia ma disposti a lottare e a dar voce a quel massacro e a quegli orrori. Quest’abominevole brutalità, fin dallo Studio per la composizione di “Guernica” (VII), reinterpreta le enigmatiche prodezze del Minotauro che, nell’opera finale, è collocato alla sinistra del cavallo, insieme alla madre con il figlio morto.

Anche i disegni – eccezion fatta per lo Studio per una testa piangente (I) e per Testa piangente (VI). Post scriptum a “Guernica” nei quali Picasso impiega alcune macchie di colore in corrispondenza di occhi, lacrime, lingua, naso e bocca – sono tutti realizzati in bianco, nero e nelle varie gradazioni di grigio. Colori che esaltano la drammaticità, la morte, il dolore, l’assenza di vita, la disperazione, la crudeltà.
Dell’ultima sezione della mostra, “Natura e Cultura”, due sono le opere che rispecchiano tale binomio: il carboncino picassiano La nuotatrice del 1934 e la tela di Óscar Domínguez (1906-1957) Composizione cosmica, del 1938.
La nuotatrice si inserisce nel ciclo dedicato alle Bagnanti; in essa i piani e le forme del corpo si compenetrano con quelle della spiaggia e del mare, fondendosi in quel “panismo” già esaltato da Gabriele D’Annunzio nella Sera fiesolana (1899) e da Giuseppe Ungaretti ne I fiumi (1916), solo per citare due capolavori poetici contemporanei a Picasso. La Composizione cosmica di Domínguez se da una parte evoca le fisionomie naturali e la natura vulcanica della sua terra natia, le isole Canarie, dall’altra sembra voler rappresentare la fuga dell’Io, dotato di ali scheletriche, da quel mondo ormai distrutto, del quale rimangono solo alcune rovine.
Al di là dell’insieme delle opere riunite, la Mostra ha due aspetti negativi: primo, di Picasso – tolta la curata sezione dei disegni – ci sono pochissime opere esposte, solo dieci tele, delle quali tre con lo stesso soggetto Il pittore e la modella. Sarebbe necessario, da parte del curatore, ripensare il titolo, inglobando anche Picasso nella modernità spagnola; secondo, le didascalie delle opere esposte sono pessime, non esaltano l’opera artistica in sé ma si estendono a pareri e/o considerazioni che, troppo spesso peccano di soggettività, dando per scontato concetti, elementi, poetiche che l’osservatore può anche non conoscere e, quindi, non apprezzare totalmente.






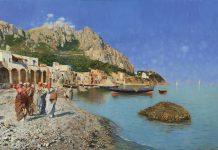






![Hokusai a Palazzo Blu: l’eredità del Maestro dell’ukiyo-e La [grande] onda presso la costa di Kanagawa (Kanagawa oki namiura), dalla serie “Trentasei vedute del monte Fuji (Fugaku sanjūrokkei)” Katsushika Hokusai ©Museo d'Arte Orientale Edoardo Chiossone Genova](https://www.fermataspettacolo.it/wp-content/uploads/2024/11/La-grande-onda-presso-la--100x70.jpg)
