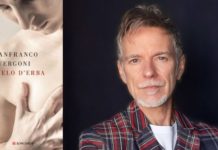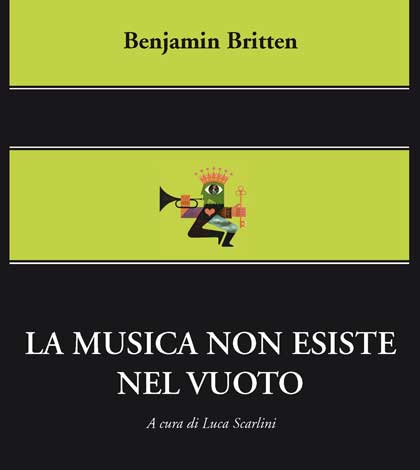
[rating=3] Nell’anno del centesimo anniversario dalla nascita di Benjamin Britten (1913-2013), una piccola ode in suo onore, per ravvivarne e rinforzarne il pensiero e la memoria: “La musica non esiste nel vuoto” a cura di Luca Scarlini.
Il critico riesuma la voce del grande compositore nella pratica edizione di Castelvecchi Editore: un’opera snella, preceduta da un’efficace introduzione per addetti ai servizi e non. Quindi passa la parola a Benjamin, la cui forza espressiva sbalordisce ancora oggi, affascina i curiosi, rende giustizia al difficile ruolo, non sempre compreso, del compositore, per un affresco di vita sincero e moderno.
“Scrivo musica per gli esseri umani, in modo deciso e diretto. Prendo in considerazione le loro voci: l’estensione, la potenza, la sottigliezza e la potenzialità di colore. Esamino gli strumenti che essi suonano…” esordisce Britten, che fin da ragazzo era fermamente convinto di fare il compositore, un mestiere difficile nell’oggi, “un misto tra lavoro su commissione e lavoro per se stessi”, con la consapevolezza che “non ha senso avere delle idee, se non si riesce a portarle in fondo”.
“Se volete sapere perché ho cominciato a scrivere è perché mi piaceva moltissimo la musica”, un’arte che costituisce un mondo a sé, fascinosa grazie al “quid che emerge da essa, e che pure la trascende, che non può essere analizzato, perché non ne fa parte, ma è suo elemento costitutivo (…) In una parola io la chiamo magia, una caratteristica che non viene riconosciuta dagli scienziati, e che per me ha valore più di ogni altra parte della musica”.
Su questo flusso di pensiero, l’ascoltatore riveste un ruolo a dir poco necessario: “la musica chiede a un ascoltatore più del semplice possesso di un registratore o di una radio. Domanda preparazione, sforzo, un viaggio verso un luogo preciso, mettere da parte i soldi per il biglietto, forse un po’ di lavoro a casa sul programma, di affinare le orecchie e aguzzare l’istinto. Richiede altrettanto sforzo da parte del compositore, come altri due angoli del triangolo: il sacro triangolo di compositore, esecutore, ascoltatore.” Sforzo empatico oggi sempre più attuale e imprescindibile: prima di bollare come “brutta” un’opera di un autore contemporaneo ascoltata alla radio o su disco, “bisogna ricordare che ogni tanto l’esecuzione può esserne responsabile (…) Chiedo solo di non liquidare un compositore, finché non abbia avuto una vera occasione”.
Insegnamenti preziosi, per ogni educatore musicale ed educando, propri di un Maestro dedito ad una ricca attività educativa e sociale, fermamente convinto che “la musica non esiste nel vuoto”, in quanto deve porsi continuamente in relazione con il mondo circostante e con l’umanità che vi gravita intorno, per adeguare ad essa il suo linguaggio: “E’ sciocco offrire ai bambini musiche che li annoiano, o che li fanno sentire inadeguati o frustrati. Un’esperienza che potrebbe farli rivoltare per sempre contro la musica: è offensivo rivolgersi a qualcuno in una lingua che non capisce.”
Un saggio semplice e impegnato, che fa della musica e della composizione una vocazione.