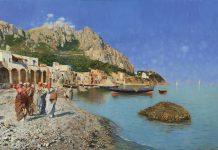Se dovessimo dire quando e perché è nata l’architettura, dovremmo dire che probabilmente è avvenuto per rispondere a un bisogno primario dell’uomo, quello di ripararsi dall’ambiente esterno. Una volta al riparo, all’uomo sarà sorto il desiderio di definire e organizzare meglio gli spazi entro i quali vivere, mangiare, procreare, socializzare…
Poi forse il suo sguardo è tornato a volgersi all’esterno e, risolto il problema dell’abitare, l’uomo ha immaginato di poter modificare l’ambiente per rispondere ad altre necessità: lavorare e produrre, certo, ma anche celebrare, ricordare, pregare, dare nuovi significati agli spazi sulla terra o magari tentare di avvicinarsi al cielo.
Così gli uomini hanno iniziato, e continuato fino ai giorni nostri, a dare vita a delle “Architetture inabitabili”, concetto che dà il titolo alla mostra inaugurata il 24 gennaio e visitabile fino al 5 maggio alla Centrale Montemartini di Roma, secondo polo espositivo dei Musei Capitolini, a pochi passi dalla stazione ostiense.

Circa 150 immagini ritraggono, analizzano e indagano otto strutture architettoniche che nell’ultimo secolo l’uomo ha “tirato su” per farne tutto ciò è diverso dal viverci.
Sono state raccolte foto di grandi autori italiani come Gianni Berengo Gardin, Guido Guidi, Marzia Migliora, Gianni Leone e molti altri, oltre a nomi internazionali quali Mark Power, Sekiya Masaaki e Steve McCurry. Le immagini di Francesco Jodice e di Silvia Camporesi sono invece state appositamente commissionate per la mostra.
Muoversi tra le sale dell’esposizione è come fare un viaggio a zig-zag in un’italia semideserta, scoprendo paesaggi in cui la presenza umana è estremamente rarefatta e dove sono proprio le architetture inabitate e inabitabili a dominare e definire i luoghi, rendendoli memorabili e irripetibili.
Si parte dall’estremo nord, Val Venosta, Trentino – Alto Adige, dove nel 1950 per alimentare una nuova centrale idroelettrica si creò un bacino d’acqua artificiale – il lago Resia – che sommerse l’intero borgo di Curon, lasciandone emergere a ricordo solo la parte superiore del campanile romanico, che oggi spunta dall’acqua in un’atmosfera surreale, immobile nello spazio e nel tempo.

Il viaggio prosegue tra gli ex “Seccatoi” di Città di Castello, originariamente usati per l’essiccatura delle foglie di tabacco. Nel 1966 vennero utilizzati per far asciugare i libri alluvionati di Firenze e oggi ospitano gli ultimi grandi cicli pittorici di Alberto Burri.
Con un salto verso sud siamo al Parco dei Palmenti di Pietragalla, in Basilicata, dove si possono ancora ammirare le oltre duecento architetture rupestri, un tempo usate dai vignaioli del posto e oggi rimaste a dare al paesaggio un tocco fiabesco e suggestivo unico nel suo genere.
Tornati al nord, in Veneto, ad Altivole in provincia di Treviso, c’è l’ultima e una delle più originali opere dell’architetto Carlo Scarpa: il Memoriale Brion, luogo di sepoltura per la famiglia Brion, che negli anni ‘60 produceva i ricercati televisori di design Brionvega. Un avveniristico complesso di forme che prende spunto da diverse ispirazioni religiose.
Ci spostiamo a nordovest per lanciare sguardi inediti a un’opera che tutti conosciamo almeno di nome, ma che probabilmente non abbiamo mai visto con gli occhi dell’architetto e del fotografo: il Lingotto di Torino, tempio dell’industria automobilistica italiana, per molti decenni uno dei simboli della città.

All’estremità opposta del Paese, in Sicilia, nella Valle del Belice per la precisione, il Grande Cretto è l’enorme creazione in cemento bianco con cui l’artista Alberto Burri ha inglobato le macerie della città di Gibellina, distrutta dal terremoto del 1968.
Di nuovo al nord, con rotta Milano, dove si alza al cielo una sorta di piccola Eiffel italiana: la Torre Branca (ex Torre Littoria), progettata da Giò Ponti come struttura temporanea per la Triennale del 1933, rimasta fino ad oggi e dalla cima della quale, dopo anni di abbandono e il successivo recupero, nel 2002 si è tornati a poter ammirare il panorama di Milano.
Dopo aver percorso più volte l’Italia da nord a sud ci si ferma infine al centro, a Roma, dove proprio nei pressi del luogo che ospita la mostra sorge il “grande Gazometro”, realizzato nel 1937, struttura simbolo di una città e di un Paese che crescevano e avevano fame di energia, al punto di cambiare per sempre il volto di intere zone della città. Divenuto vera e propria icona dello skyline della capitale e di tante scene del cinema italiano (da Pasolini a Özpetek), il gazometro lo si potrà anche vedere dal vivo, svettante sul quartiere ostiense, appena usciti dalla Centrale Montemartini.

C’è un’ultima tappa di questo viaggio, al piano superiore, dove tre maxischermi proiettano in loop filmati di varie epoche, provenienti dall’archivio Luce e altri archivi e istituzioni, dedicati alle “architetture inabitabili”.
Il che offre l’opportunità di percorrere e conoscere meglio anche quella che potremmo considerare a sua volta un’ennesima architettura inabitabile, la stessa Centrale Montemartini, il primo impianto pubblico di Roma per la produzione di energia elettrica, oggi mirabile esempio di recupero e riconversione, in cui convivono archeologia industriale, antichità romane ed eventi (con)temporanei.