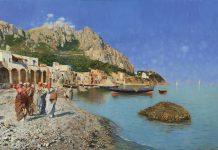[rating=4] Nel Palazzo Pretorio di Prato, attraverso le varie sale della mostra titolata “Da Donatello a Lippi” è stato possibile delineare uno spaccato artistico del Quattrocento pratese, fiorentino e toscano, in generale. La Toscana, liberatasi dalla peste nera (1348) e dalla fiorentina Rivolta dei Ciompi (1378) torna ad esprimere e imporre la propria volontà culturale, e lo fa, ancora una volta, con l’Arte.
Seguendo le opere della Mostra è importante sottolineare che, in quegli anni, a Firenze si completano i più antichi cantieri architettonici da Santa Croce a Santa Maria Novella al completamento del Duomo con la cupola del Brunelleschi, così come a Prato si definiscono i lavori della Cattedrale.
Le città toscane cono dei fervidi e innovativi microcosmi spirituali e culturali, culle dell’Umanesimo e del conseguente movimento artistico del Rinascimento, in competizione con le più potenti e lussuose corti europee. Si abbandonano i secoli bui del Medioevo e si cerca una nuova luce, una nuova vita che innalzi l’uomo sopra le antiche barbarie e lo faccia rinascere, ponendolo al centro dell’Universo. Ed ecco che ha inizio l’avventura antropocentrica, a partire dalle tavolette prospettiche del Brunelleschi, del 1415, con la conseguente razionalizzazione figurativa dello spazio.
E la Mostra pratese si apre proprio con questo anno, il 1415, con tre opere di Donatello, La Madonna col Bambino, due angeli e profeti, La Creazione di Eva, La Madonna col Bambino, tutte sculture in terracotta, la prima del Museo pratese, la seconda del Museo dell’Opera del Duomo, la terza del Museo Nazionale di Villa Guinigi di Lucca. In queste opere è possibile notare come la scultura di Donato di Niccolò di Betto Bardi, alias Donatello, vada oltre quella naturalista. Si tratta di una scultura già realista, discendente da quella della Roma repubblicana e da quella etrusca, con reminiscenze ghibertiane. Traspare dalle tre sculture una nuova umanità, i panneggi delle vesti della Vergine e i nudi di Adamo ed Eva esaltano l’anatomia delle figure e i loro sentimenti.

Da Donatello a Paolo di Dono detto Paolo Uccello, considerato il più grande maestro della prospettiva della sua generazione. Del pittore aretino meritano menzione San Giorgio e il Drago, una tempera su tavola con foglio argento, proveniente dalla National Gallery of Victoria di Melbourne (Australia), realizzata tra il 1423 e il 1425, e L’Adorazione del Bambino con i Santi Girolamo, Maria Maddalena ed Eustachio, conservata alla Staatliche Kunsthalle di Karlsruhe (Germania), realizzata nel 1436.
Nella prima opera emergono in primo piano le coppie delle figure: a sinistra San Giorgio e il drago, impegnati nel duello, resi con toni scuri; a destra, il bianco cavallo e la figura, quasi angelicata, di blu vestita, della giovane principessa. Oltre il primo piano, un secondo livello prospettico ci propone un ambiente totalmente surreale, oserei dire già avanguardista, costituito di rosse e fiammanti colline sulle quali poggia la città, le cui costruzioni e mura sono di colore rosso-blu. Dal cielo dorato il Padre dei Cieli abbraccia la scena e segna la vittoria dell’eroe cristiano sull’orribil bestia.
Con la seconda opera, una tempera con oro su tavola, ci troviamo immersi in un’atmosfera fiabesca. La scena sacra ha molti spettatori, si tratta di una novità assoluta, un’idea rivoluzionaria: i tre Santi, seppur collocati nella grotta, entrano nel momento cardine della Cristianità. Altro elemento sorprendente, la lontananza del bue e dell’asinello, genuflessi all’estrema sinistra dell’opera, accanto ad una palma prospettivamente geometrica e indipendente dal resto dell’ambiente, al confine col mare dal quale giungono due navi con vele bianche, illuminate da una stilizzata ma brillantissima stella cometa. Scena totale alla quale prendono parte molti animali: dal leone di San Girolamo, al cane e al capriolo di Sant’Eustachio. L’attenzione di tutti i viventi è verso il Bambino, eccezion fatta per San Giuseppe che, in secondo piano rispetto alla Vergine con Gesù, sembra assorto in un meditativo sonno notturno.
Ultima inquietante opera del maestro aretino, a conclusione della sezione titolata “La giovinezza di Paolo Uccello” è collocata l’opera Santa Monica [o Santa Monaca?] in preghiera con due fanciulli, tempera su tavola conservata alla Galleria degli Uffizi, forse facente parte di un più ampio progetto pittorico, una pala d’altare di maggiori dimensioni non pervenutaci. Da un fondale color porpora si staglia l’imponente figura di Santa Monica in abito monacale nero, con un rosario in mano. La stanza è prospettica e gioca sui colori porpora, nero e oro. In basso a sinistra, ai piedi della Santa, si vedono due fanciulli che pregano, in netto contrasto cromatico con l’imponente figura in primo piano.
Da Paolo Uccello a Zanobi Strozzi e Domenico di Michelino. Entrambi analizzano il tema del viaggio dei Magi. Strozzi dipinge il Viaggio del re magio Baldassarre (1440-1445) e Domenico di Michelino Il re magio Gaspare naviga verso la Terra Santa (1440-1445). Elementi comuni alle due opere i colori brillanti, l’uso spiccato degli ori, la meticolosa rappresentazione dei doni portati in viaggio dall’Oriente a Gerusalemme, fino a Betlemme per adorare la nascita di Gesù, Re dei Giudei.

Ed è soprattutto l’opera i Zanobi Strozzi che richiama una maggiore attenzione e, soprattutto, sorge spontaneo l’accostamento visivo all’opera di Benozzo Gozzoli, titolata Viaggio dei Magi (1459), di poco posteriore, commissionata da Piero de’ Medici e facente parte del ciclo di affreschi della Cappella dei Magi in Palazzo Medici Riccardi a Firenze. Con Zanobi Strozzi, come in Benozzo, si diventa spettatori del corteo, caratterizzato da preziosismi ed esotismi bizantini. Il paesaggio è ricco di dettagli, dai castelli, agli animali, alle piante fantastiche. Il realismo delle figure umane, dei loro abiti e, soprattutto, dei loro volti è sorprendente, allo stesso tempo, consueto per l’arte rinascimentale.
Una delle opere più preziose che apre la sezione dedicata a Filippo Lippi è la Madonna col Bambino proveniente dal Museo di Arte Sacra di Montespertoli e realizzata dal pittore intorno al 1445.
La figura della Vergine abbraccia il Bambino, dal corpo fasciato, ed emerge da un tabernacolo quasi a creare un effetto tridimensionale, forse dovuto dalla rotondità della tavola. Il nero mantello della Vergine contrasta con l’abito porpora e con il puro bianco delle fasce che proteggono Gesù. Così come sembrano uscire dalla tavola e materializzarsi i volti e gli sguardi del duo protagonista.
Di tutt’altro stile e carattere è la Madonna del Ceppo databile intorno al 1452-1453 e conservata in Palazzo Pretorio. Qui Lippi mostra, su un fondale oro, la Madonna in trono col Bambino, ai suoi fianchi San Lorenzo (a sinistra) e San Giovanni Battista (a destra). In basso a sinistra, ai piedi del trono della Vergine, il mercante Francresco Datini che le presenta i quattro committenti. L’opera, già dal titolo, vuole essere un omaggio del pittore alla Pia Casa dei Ceppi, detta il Ceppo, un’istituzione assistenziale nata a Prato grazie al lascito del mercante Datini, nel 1410. Le elemosina a sostegno del Ceppo venivano inserite in un ceppo d’albero che aveva sede in Palazzo Datini. L’opera fu commissionata a Lippi dai quattro Buonomini del Ceppo, i quattro committenti presentati alla Vergine, che sovrintendevano alla decorazione della Cappella Maggiore di Santo Stefano nel Duomo di Prato.
Di grandiosa bellezza ed eleganza è la Natività del cristo realizzata dal Lippi intorno al 1455 e oggi conservata agli Uffizi. Nei primi anni di lavoro a Prato, Lippi realizza questa tempera su tavola per il Convento fiorentino dei Domenicani, fondato nel 1455 da Annalena Malatesta. In primo piano la scena della Natività di Cristo con San Giuseppe, il Bambino e Maria. Da loro parte una prospettiva profonda che fonde gli altri elementi dell’opera: il bue e l’asino al centro, la Maddalena sulla destra, il vecchio e barbuto San Girolamo che prega inginocchiato sulla sinistra della scena e, poco più in basso, il monaco Sant’Ilarione, proveniente da Gaza, solitamente ricordato come taumaturgo, abate e fondatore di monasteri in Terra Santa, nel quale la più accreditata critica d’arte sembra riconoscerci il ritratto di Roberto Malatesta, fratello di Annalena, la fondatrice del Convento. Colori caldi e freddi delle vesti del trio della Natività si fondono in una perfetta armonica, dando all’opera un senso di grande equilibrio non solo strutturale ma visivo e, più in generale, sensorialmente percettivo.

Da qui ad il “tondo di stanza” lippiano che richiama alla mente il Tondo Doni di Michelangelo, di poco posteriore (1504-1506), sia come dimensioni sia come tematica. È infatti identificato come Tondo Bartolini, dal mecenate che glielo commissionò, Leonardo Bartolini, e l’elemento che lo contraddistingue è uno spiccato senso di teatralità. È l’unico tondo del Lippi e si avvale della tradizione pittorica medievale che unisce, in un’unica soluzione, in un unico momento, spazi ed eventi storici diversi. Al centro la Madonna col Bambino che sta mangiando i semi di una melagrana (simbolo della sua Passione e Morte), in basso a destra alcune figure femminili che portano doni alla puerpera – che nelle vesti prelude alla futura realizzazione botticelliana de La primavera (1482) nelle figure della ninfa Clori, la protagonista Flora e il trio delle Grazie – in alto a sinistra si ha la nascita della Vergine Maria e, in alto a destra, l’incontro di Anna con Gioacchino alla Porta Aurea. Tutto il Tondo è giocato su contrapposizioni di rosso scarlatto, nero e bianco e nelle loro sfumature, ora più chiare ora più scure, con un senso prospettico multiforme e razionale che li lega insieme, creando spazi cromatici nitidi, sui quali si stagliano ed emergono le figure in movimento.
Commissionata a Lippi da Geminiano Inghirami per la Cattedrale di Prato è l’opera Esequie di San Girolamo (1455-1460), una pala d’altare oggi conservata nel Museo dell’Opera del Duomo della città. Al centro, disteso sul catafalco, il corpo del Santo, circondato dai monaci che, in un dolore silenzioso ma visibile, gli stanno attorno. Soggetto che richiama alla mente, soprattutto per le figure dei monaci dolenti, gli affreschi di Giotto per la Cappella Bardi nella Basilica di Santa Croce a Firenze. Il committente Inghirami si ritrova nell’opera, in basso a destra, vestito riccamente di rosso, inginocchiato insieme ad un fanciullo che indica allo spettatore da dove osservare la scena. Accolgono l’anima del Santo diverse schiere angeliche dantescamente concentriche, quelle del Paradiso, con Gesù a braccia aperte, le colombe dello Spirito Santo e, più in alto il Redentore. Opera eccezionale per la resa delle reazioni emotive dei personaggi, sottolineate con forme morbide intessute di luce.
Il più stretto collaboratore di Filippo Lippi, nonché primo maestro di Filippino, il figlio che Fra’ Filippo ebbe dall’unione amorosa con la monaca Lucrezia Buti, fu Fra’ Diamante, religioso carmelitano attivo in area fiorentina e pratese. Di lui, giunte in prestito dal Szèpmuvèszeti Mùzeum di Budapest, originariamente proveniente dall’Oratorio di San Lorenzo, è la pala d’altare titolata Madonna col bambino, con i Santi Lorenzo e Antonio (ca. 1470). L’opera è realizzata intorno al 1470 quando Fra’ Diamante fu richiamato a Prato, dopo la morte di Fra’ Lippi nel 1469. il suo stile è accostabile sia alla pittura fiamminga sia all’arte contemporanea perchè spiccano subito agli occhi dello spettatore tagli netti di luce, ricchezze di particolari, scenografie prospettiche dai molteplici punti di fuga.
Da Fra’ Diamante a Filippino. Del figlio di Filippo è interessante il piccolo Crocifisso, un dipinto a tempera su tavola, databile tra il 1500 e il 1504, tornato nel Comune di Prato nel 2010 e, ad oggi, conservato nel Museo Civico della città. È un’opera della maturità nella quale il Cristo in croce emerge da un fondale nero. Una realizzazione intima, di devozione quasi privata con una grande attenzione all’anatomia, dai muscoli, agli arti, al sangue che esce dalle ferite. Una raffinata eleganza sia nelle proporzioni sia nel gioco dei chiaroscuri che lo accosta all’opera omonima del suo maestro, Sandro Botticelli, il cui Crocifisso (1496) conservato al Museo di pittura murale di Prato, è di pochi anni anteriore.
Un percorso cronologicamente ben strutturato, con tematiche ricorrenti dell’arte sacra del Rinascimento, che ha messo in luce, accanto ai più alti Maestri del periodo, tanti eccellenti pittori “minori” ma grandi “cronisti di costume” dell’epoca. Sarebbe stato opportuno inserire più opere di Donatello, come sottolineato in apertura dal titolo della Mostra, per creare un equo bilanciamento con la produzione di Filippo Lippi e Filippino.