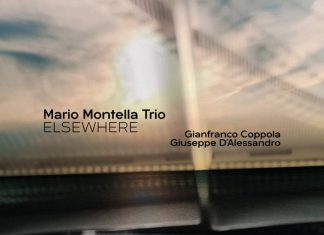È affetto, il giovane conte Gil, da una ben grave forma morbosa di patologia sociale, che gli fa prender sovente lucciole per lanterne e veder fuoco là dove c’è solo… fumo: da poco tempo sposo felice di Susanna, ne è geloso al parossismo, immaginando chi sa che incontri, vedendola passeggiar sola soletta per la città, sperando in un errore, rientrando trafelato a casa, augurandosi di cuore di trovarla invece in salotto a tormentare il pianoforte. E lei, in effetti, è là, rientrata in fretta e furia da chi sa che urgente commissione, profittando della lealtà e del silenzio del fido Sante, maggiordomo imperturbato e imperturbabile che segue le peripezie dei giovani padroni con l’aria dell’entomologo che studia le formiche. Come rimaner tranquilli? Anche perché da qualche tempo, un odore deciso di tabacco aleggia fra le mura, impregna tendaggi e vesti, misteriosamente, visto che nessuno della casa è dedito al vizio che per istinto schivo e detesto. Dunque è fondato pensare che un seduttore, un fumatore, sia entrato in casa. Fra litigi, ripicche, riconciliazioni, la commedia va avanti sotto l’occhio vigile di Sante – e le sue silenziose ma eloquenti sottolineature – fino al prevedibile finale: è Susanna che fuma, contrita promette di smettere, ma Gil la previene, fumeremo insieme, dice. E mentre escono di scena fumando felici – Tutto è fumo a questo mondo, come in un mini Falstaff riveduto e aggiornato – Sante, rimasto solo, accende una sigaretta per sé, prima di spegnere il lume e uscire anch’egli, lasciando che la luce della luna, dalla finestra, illumini la nuvola di fumo nella stanza.

Qui all’Aperia della Reggia di Caserta, elegante struttura recuperata da poco per la fruizione di spettacoli all’aperto – e con grande perspicacia, vista l’amenità del luogo, accanto al Giardino Inglese del Parco, e l’ottima acustica, che rende possibile la rappresentazione musicale – è la volta del secondo titolo della minirassegna Festival dell’Opera buffa Napoli e l’Europa, dopo la la Serva padrona. E con l’Intermezzo di Pergolesi, modello di un certo tipo d’opera buffa, elegantissimo e perfetto nella sua conchiusa miniatura, molti sono i punti in comune de Il segreto di Susanna, del veneziano Ermanno Wolf-Ferrari, a cominciare dalla brevità, a dimostrazione di quanto la formula d’opera da camera sia durata nel tempo e, per certi versi, tuttora risulti attuale. Due personaggi – destinati ad innamorarsi, o a ritrovarsi, come nel più moderno dei lavori – e le loro schermaglie, animano la scena, con un servo muto a far da paraninfo, silenzioso testimone di tutti noi, del pubblico che assiste, con tenerezza e benevolenza, a ciò che sul palco si va svolgendo: teatro da camera, adatto, certo, a raccontare storie private, minimali, non certo la Storia con la S maiuscola. Tuttavia, chi dice che in certe piccolezze, in talune incertezze, in talaltre goffaggini del privato non sia possibile – certo per intuizione – risalire ai grandi movimenti della storia? In fondo, nell’anno di grazia 1909, quando fu rappresentato per la prima volta, a Monaco, in tedesco, Susannens Geheimnis, Sigmund Freud aveva già dato da tempo alle stampe Psicopatologia della vita quotidiana, fra qualche anno il quasi conterraneo Svevo indicherà proprio in quel fumo di sigaretta e nel vizio del tabacco la (mancata) possibilità di riscatto del prototipo dell’inetto, e in quanto alla vita di coppia, quasi contemporaneamente Luigi Pirandello ne esplorerà tutte le inusitate evenienze e potenzialità e i lati oscuri e sfuggenti.

Ma certo tutto questo appare un po’ lontano, pur se contemporaneo, al Segreto di Susanna e al modo con cui certe tematiche – la vita di coppia, la dipendenza, il rifugio dalla noia (spesso al circolo tu ten vai degli amici… io passo il tempo…) – vengono trattate e risolte. Perché questo, poi, è in definitiva, l’arte di Wolf-Ferrari, lui che era tra i pochi, a quel tempo, a poter campare dell’arte sua, come i grandi dell’epoca, Puccini e Strauss, Mascagni e Giordano, pur tenendosi accuratamente fuori dal verismo e dalla Giovane Scuola (per non parlar di Berg…): teatro dall’apparenza leggera che, tuttavia, a ben vedere, stempera la limpidezza di certi astratti orizzonti, tanto sereni d’apparir perfino fuori posto, nel turbinoso inizio del secolo breve, in un nitore mitteleuropeo eticamente saldo e intangibile. Il risultato finale di queste opposte tensioni è quell’atmosfera d’improbabile pacifica inquietudine, così tipica nell’opera sua, da giustificar l’ossimoro solo in virtù dell’innata onestà che trapela da ogni nota, da ogni accento, da ogni melodia, pur aspettandoti ad ogni giravolta il baubau, l’esito risolutore, o almeno l’ambiguo, l’obliquo. Nulla, invece. E quando la forza della Storia irruppe in questo mondo così ispirato allo zeitlose mozartiano e, insieme, alla bonaria critica borghese di Goldoni, perenni stelle polari del suo percorso, non seppe altro che rimanere, come annichilito, in silenzio, per oltre dieci anni.

E allora non può che essere, lo spazio scenico creato dal regista Francesco Saponaro, complice la matita di Lino Fiorito che disegna pure i costumi, che ricompreso tra due candidi paraventi art déco, a linee verticali l’uno, a motivi circolari l’altro, cui rispondono sul davanti due semplici oggetti di scena: un vaso da fiori su una colonna e uno stilizzato sofà dalle linee pulite e razionaliste a richiamare quegli anni. L’estrema semplicità della scena è il corrispettivo della stilizzata materia che si va a metter in scena, i paraventi han funzione di quinte teatrali – a ricordarci sempre dove ci troviamo e cosa stiamo facendo, ma niente Brecht, per carità – il vaso servirà – non sembri scontato – a metterci i fiori, il sofà a sedercisi e a Sante per nascondercisi sotto – non vi venga in mente il sofà dello psicanalista, per carità – come nel migliore dei vaudeville. Maria Katzarava ha la voce morbida ma particolarmente intensa e il carattere che ben s’addice alla Susanna, donna pronta ad emanciparsi – ma non troppo: molto a suo agio e sicurissima nell’acuto, sempre pieno, sa regalarci un personaggio estremamente espressivo nelle sfumature e nei particolari; pure Sergio Vitale ha saputo render bene le incertezze e le passioni del conte Gil, grazie alla pulizia della sua vocalità che ha saputo venare di sfumature perfino drammatiche: il cantante casertano ha voce di vero baritono, ma sale facilmente all’acuto e così, insieme ad una rilevante esuberanza scenica, ha saputo rendere alla perfezione il personaggio del marito un po’ gigione; il cast si completa con la presenza silente di Luciano Saltarelli, visto di recente al Napoli Teatro Festival con la sua Quel gran pezzo della Desdemona, che riesce a trovare la giusta dimensione per disegnare un maggiordomo muto sapientissimo e ironico in equa misura, senza mai cadere nel grottesco, contribuendo così in maniera decisiva alla riuscita della messa in scena, sempre elegante. La direzione della piccola ensamble si avvale del gesto sicuro di Giovanni Di Stefano, che indovina il tono più vero per questa partitura, eternamente sospesa tra bonaria ironia e abbandono: il che, alla fine, è con esattezza ciò che è, e ciò che si prova ascoltandola.