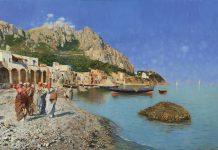Nella bella Firenze, culla del Rinascimento, si respira aria di nuova primavera nel cuore pulsante di Palazzo Strozzi: fino al 18 agosto è in mostra La Primavera del Rinascimento. La scultura e le arti a Firenze 1400-1460.
“Siamo nati non per fare mostre ma per arricchire la città di Firenze – afferma il lungimirante direttore James M. Bradburne – ogni mostra serve per visitare questa meravigliosa città, ridarle il suo palazzo storico per eccellenza, metterlo al suo servizio”.
E Palazzo Strozzi si inchina al Rinascimento in tutto il suo splendore esponendo 140 opere, capolavori assoluti, provenienti da musei di tutto il mondo: opere di qualità straordinaria che mettono in luce il ruolo guida che la scultura ha avuto nella prima metà del Quattrocento per la nascita e lo sviluppo del linguaggio rinascimentale e la sua incidenza soprattutto sulla pittura fiorentina contemporanea, come sottolinea lo stesso Vasari nelle sue Vite:
«Dico dunque che gli scultori, come dotati forse dalla natura e dallo esercizio dell’arte di migliore complessione, di più sangue e di più forze e per questo più arditi et animosi de’ nostri pittori, cercando di attribuire il più onorato grado alla arte loro, arguiscono e provano la nobilità della scultura primieramente dalla antichità sua, per aver il grande Iddio fatto lo uomo, che fu la prima scoltura, dicono che la scultura abbraccia molte più arti come congeneri e ne ha molte piú sottoposte che la pittura, come il basso rilievo, il far di terra, di cera o di stucco, di legno, d’avorio, il gettare de’ metalli, ogni ceselamento, il lavorare di incavo o di rilievo nelle pietre fini e negli acciai, et altre molte, le quali e di numero e di maestria avanzano quelle della pittura; et allegando ancora che quelle cose che si difendono piú e meglio dal tempo e piú si conservano all’uso degli uomini, a beneficio e servizio de’ quali elle son fatte, sono senza dubbio piú utili e piú degne d’esser tenute care et onorate che non sono l’altre, affermano la scultura essere tanto piú nobile della pittura, quanto ella è piú atta a conservare e sé et il nome di chi è celebrato da lei ne’ marmi e ne’ bronzi contro a tutte le ingiurie del tempo e della aria, che non è essa pittura, la quale di sua natura pure, non che per gli accidenti di fuora, perisce nelle piú riposte e piú sicure stanze che abbino saputo dar loro gli architettori».
L’elogio alla scultura rinascimentale è assoluto, gravido di un messaggio che non dovremmo mai dimenticare, come sottolinea Leonardo Bieber: «Ci ricorda il primato dell’arte per mantenere il benessere e la bontà della politica (…) perché la cultura è strettamente legata all’economia (…) Il contesto culturale ci può far uscire dalla crisi: ecco dunque una mostra che rappresenta un momento di crescita per tutti e trasmette un forte messaggio di speranza per il futuro».

Parlare di Rinascimento a Firenze potrebbe sembrare ovvio: Firenze è madre del Rinascimento, possiede già il più grande patrimonio rinascimentale del mondo. In realtà tale immagine è fuorviante, la smentiscono immediatamente le parole di Bradburne: «Molte opere rinascimentali fiorentine sono andate disperse nel corso dei secoli, grazie a questa mostra sono tornate a casa: abbiamo riportato il Rinascimento a Firenze (…) in una splendida giornata di sole e con l’inizio della primavera».
Un progetto dunque straordinario, come evidenzia la sovrintendente del Polo Museale Fiorentino Cristina Acidini, grazie ai “prestiti di musei straordinari e ad uno straordinario catalogo pieno di saggi e schede edito dalla Mandragola”.
«La collaborazione con musei stranieri non è una novità – continua – ma un valore: è un progetto fin dal principio condiviso dal Louvre e dal Bargello, due musei che potevano già garantire una base affidabile e ricca per la scultura del Rinascimento. Il peso fisico di questi bronzi è tale da aver fatto tremare i polsi dei curatori: eppure tali bronzi ci sono, è stata data completa fiducia al progetto (…) Perché il Rinascimento nasce a Firenze? Lo stesso Vasari ha aspettato prima di rispondere: forse per la potenza dettata dall’ispirazione dell’antico, Firenze diventa un nuova Roma Repubblicana. Ma pensate a oggi: se gli artisti si lasciassero ispirare dalle creazioni del 1200 ne trarrebbero energia? Non lo sappiamo. Forse però sta proprio rinascendo un confronto fra antico e moderno, confronto che vede i secondi tentare di superare i primi, come trapela dalla prossima mostra del 28 marzo alla Strozzina Un’idea di bellezza».
Dunque progetto straordinario, nato nell’arco di ben 4 anni di collaborazione e ideazione tra Palazzo Strozzi, Louvre e Bargello, come sottolinea la curatrice Beatrice Paolozzi Strozzi. «L’idea è nata direttamente dal presidente e direttore del Louvre, dopo il successo della mostra su Desiderio da Settignano: è lui che ha proposto nel 2007 una grande mostra sulla scultura. Abbiamo considerato l’idea confusa di Rinascimento che domina il pensiero comune, legata essenzialmente ad autori quali Raffaello, Leonardo, Michelangelo o la grande maniera del Cellini, Bronzino, Giambologna. Molto più raramente ci si è soffermati sulla prodigiosa fioritura artistica, culturale, politica e sociale, quali gli ideali liberali della Firenze di quegli anni. La scultura a questo proposito riveste un ruolo primario: è l’arte che si è fatta per prima interprete di questa nuova bellezza (…) Ecco allora il perché di questa mostra che da settembre arriverà anche al Louvre di Parigi identica a quella attuale qui a Firenze: il progetto si è realizzato nella forma migliore.»
La mostra illustra 10 sezioni tematiche, allestite magistralmente; i temi sono scelti tra quelli peculiari, come diversi capitoli di un libro, capolavori della scultura anche monumentale. Molte di queste opere sono state restaurate nel corso di questi ultimi due anni, in collaborazione con il Louvre, come il mastodontico San Ludovico di Tolosa, bronzo dorato di Donatello.

Il libro si schiude, accattivante e magico, su un passato glorioso, che è giusto, proprio in questa difficile congiuntura storica ed economica, tenere a mente come modello di speranza, perché, come ci insegna Cicerone, “Historia magistra vitae“. Eccoci allora nell’epica Repubblica fiorentina, la cui potenza economica e pace sociale, diffondono attraverso gli scritti degli umanisti il mito di Firenze come erede della repubblica romana e come modello per gli altri stati italiani. La scultura pubblica monumentale di Donatello, Ghiberti, Nanni di Banco, per la Cattedrale e per Orsanmichele, testimonia la “rivoluzione” culturale avvenuta e influenza profondamente anche la pittura. Altri temi dell’antichità classica vengono assimilati e trasformati nel nuovo linguaggio scultoreo, che esprime il clima spirituale e intellettuale della città, oltre al suo fervore creativo.
La prima sezione ci mostra L’eredità dei padri che emerge da opere di Nicola Pisano e Arnolfo di Cambio, legate a paradigmi “classici” e monumentali, ai quali si affiancano quelli del Gotico, che discendono dall’opera di Giovanni Pisano e dalla circolazione di esempi francesi.
La seconda sezione segna l’inizio tangibile del Rinascimento, ovvero Firenze 1401: l’alba del Rinascimento, con i rilievi del Sacrificio di Isacco realizzati da Lorenzo Ghiberti e Filippo Brunelleschi per il celebre concorso del 1401, che avrebbe assegnato al vincitore la seconda porta del Battistero, costituiscono una pietra miliare della storia dell’arte. Qui da sfondo il Modello ligneo della Cupola del Brunelleschi in cui si riassume la nuova concezione dello spazio e della storia, che ha origine a Firenze.
La terza sezione mostra La romanitas civile e cristiana, ovvero lo sviluppo dell’Umanesimo civile e la costruzione del mito di Firenze come nuova Roma e nuova Atene, pur non escludendo, ma anzi esaltando, un forte sentimento cristiano, che emerge proprio nella scultura pubblica attraverso le statue dei santi-eroi e dei profeti della Cattedrale.
Il viaggio prosegue attraverso i segni più visibili del Rinascimento, gli “Spiritelli” tra sacro e profano, quelle figure infantili derivate dai “genietti” della classicità romana, puttini alati nudi che compaiono nei più importanti monumenti fiorentini del primo Quattrocento, per quindi approdare verso La rinascita dei condottieri in monumenti equestri anche in piccola scala e a destinazione privata, che esaltano l’attività dell’uomo, rimarcandone il valore individuale nella storia.
La scultura, però, fa spesso ricorso alla policromia, così come la pittura si lascia influenzare dalla scultura: si osserva allora la “Pittura scolpita” che si cimentano con il tono eroico e “statuario” nella rappresentazione della figura umana, ricreando illusionisticamente la tridimensionalità della scultura coeva.

Un’altra grande rivoluzione del Rinascimento è La storia in prospettiva, portata a compimento con il contributo delle arti liberali e meccaniche al seguito della fondamentale esperienza di Filippo Brunelleschi. Celebri rilievi mostrano l’assimilazione e la traduzione da parte della scultura delle nuove leggi di costruzione dello spazio secondo la «perspectiva artificialis», cioè la scienza della rappresentazione, partecipando alla loro messa a punto e talvolta anticipandone l’evoluzione.
Il passaggio è breve per La diffusione della bellezza: madonne e altaroli destinati alla devozione privata si diffondono capillarmente, in larghi strati della società, canoni e prototipi dell’arte nuova rendendola accessibile a tutti. La tradizionale scala gerarchica dei materiali perde importanza a favore della qualità dell’esecuzione: la terracotta, arricchita dal colore e dall’oro, tende a uguagliare la preziosità del marmo o del bronzo, e in essa si cimentano i maestri come Luca della Robbia.
Ed è una Bellezza legata alla carità: gli istituti di pubblica assistenza sono oggetto delle principali committenze pubbliche nella Firenze del primo Quattrocento. L’importanza di questo rapporto tra culto della bellezza e spirito cristiano si manifesta anche nelle opere d’arte collegate al Concilio d’Unione del 1439, che sancisce il primato politico e morale di Firenze, e segna anche l’avvento del potere mediceo.
Il viaggio, ciclicamente, si intreccia nella sua spirale d’origine ed esalta il luogo che lo ha accolto: si giunge infatti Dalla città al palazzo. I nuovi mecenati. Nel nuovo Palazzo Medici, riproposto come modellino ligneo, Cosimo il Vecchio e suo figlio Piero inaugurano un mecenatismo fastoso, in cui il privato contende al pubblico le committenze artistiche più prestigiose.
Con l’auspicio che Palazzo Strozzi si trasformi in quella dimora mecenate di bellezza celebrata dal medesimo Vasari perché tali arti «nella sua felicissima casa siano rinate, e per benefizio de’ suoi medesimi, abbia il mondo queste bellissime arti ricuperate e che per esse nobilitato e rimbellito si sia».
Numerose le attività trasversali tra le quali spiccano visite tattili per vedenti e non vedenti.
Maggiori informazioni: http://www.palazzostrozzi.org